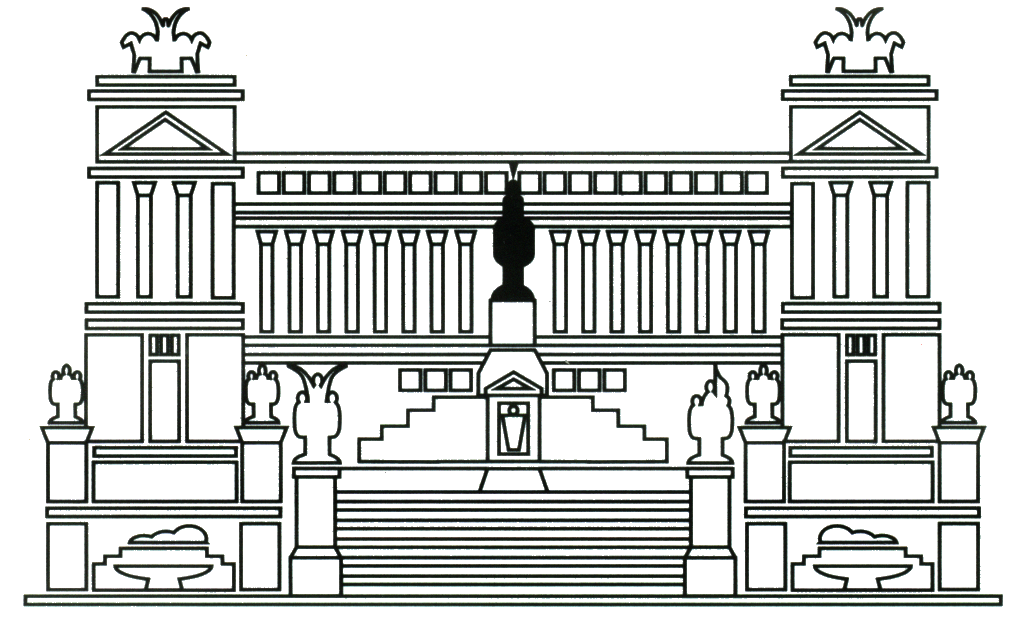Titolo originale:
Fondo AzeglianoTipologia:
fondoData:
XIX sec.Consistenza:
[non specificata]Descrizione:
La “Raccolta Azegliana” conservata al Museo Centrale del Risorgimento di Roma, fu affidata dagli eredi al Museo per volontà testamentaria delle Marchese Carolina Ricci Ciccolini e Clotilde Ricci Coronaro. E’ una raccolta molto ricca, costituita da carteggio riguardante prettamente la figura storica di Massimo d’Azeglio, da fotografie, cimeli, manoscritti e stampati. Non sono presenti solamente le lettere del Re Vittori Emanuele II che non furono consegnate con gli altri documenti. La documentazione copre un periodo che va dal 1814 al 1927 ed è sistemata, senza un ordine cronologico preciso, nelle Buste N. 561 - 572. La consistenza è di 2617 unità archivistiche. Vi è un unico documento risalente al 1535: si tratta della lettera (datata Reggio, maggio 1535) di Alberto Jacredes al Duca di Ferrara, relativa al mancato pagamento delle spese per i suoi beni e delle sue terre da parte del Conte Giulio di Nuvolara, in seguito strangolato. La presenza di tale documento all’interno del carteggio di Massimo d’Azeglio, può spiegarsi come un probabile appunto per un’eventuale opera di carattere storico.All’interno del carteggio della “Raccolta Azegliana” vi è una grande documentazione relativa alla condizione degli Ebrei:una minuta (datata 2 nov. 1847) delle Corporazioni Israelite della Toscana diretta al Granduca di Toscana per ottenere l’emancipazione civile e politica; una trascrizione del motu proprio di Papa Giulio II contro gli Ebrei (senza data); la copia di un avviso (datata Pesaro, 2 ago. 1847) dell’Inquisizione di Pesaro riguardante l’ordine per gli Ebrei di Pesaro di munirsi di licenza allo scopo di poter uscire dal Ghetto; una serie di memorie riguardanti la condizione degli Ebrei in vari stati d’Europa, le loro leggi, il Talmud; sulla condizione degli Ebrei di Roma nella prima metà dell’Ottocento ed alle restrizione loro imposte; sugli Ebrei di Toscana, sugli Ebrei del Piemonte.Vi è poi una nomina a Massimo d’Azeglio come Presidente Onorario dell’ “Institut d’Afrique, Société Internationale fondée pour l’abolition de la traite et de l’esclavage” (Parigi, 1852). ella serie delle “Fotografie” compare esclusivamente un’albumina del 1865 ritraente la “Basilica di S. Maria del Fiore. Cattedrale della Città di Firenze”.
Nella serie dei “Cimeli” si può trovare: una sacca in seta con legatura in filo d’argento nappato contenente la decorazione del Re di Tunisi Mushir Ahmed Bascià Bey conferita a Massimo d’Azeglio in data 27 nov. 1850;un sigillo in cera nera del Re Vittorio Emanuele II contenuto in una teca di metallo legato con un cordoncino verde alla Patente con la quale il Re nominava Massimo d’Azeglio come Cavaliere di Gran Croce, decorato del Gran Cordone dell’Ordine Equestre dei SS. Maurizio e Lazzaro (31 dic. 1859).Nella serie dei “Manoscritti” si trovano i seguenti documenti:
un manoscritto dal titolo “Gli Ebrei e la Guardia Civica di M. A.” di Massimo d’Azeglio (datato Roma, 8 dic. 1847). Sul frontespizio del manoscritto oltre al titolo si notano dei bozzetti a matita raffiguranti tre volti di uomini;
un manoscritto dal titolo “Gli Israeliti e la Guardia Civica” (1847) di Massimo d’Azeglio;
una traduzione manoscritta in inglese dei primi 15 capitoli dell’ “Ettore Firemosca” di Massimo d’Azeglio (senza data);
un manoscritto del I Tomo de “I miei ricordi” di Massimo d’Azeglio (senza data);
un manoscritto del II Tomo de “I miei ricordi” di Massimo d’Azeglio (senza data);
la copia del manoscritto in lingua francese di Massimo d’Azeglio dal titolo “Inedita. Copia della lettera politica a Panizzi. 1856”;
un manoscritto di Massimo d’Azeglio dal titolo “Inedito. Del Giornalismo” (senza data);
alcuni appunti e pensieri manoscritti di Massimo d’Azeglio relativi alla Lega Lombarda, intitolati “La Lega Lombarda. Pensieri, abbozzi” (1842 – 1845);
il manoscritto del romanzo incompiuto “La Lega Lombarda” di Massimo d’Azeglio in 8 capitoli (1843);
il manoscritto della Commedia in cinque atti “Le Autopsie” di Massimo d’Azeglio (senza data);
un manoscritto di Massimo d’Azeglio dal titolo “Le coincidenze” (senza data);
una lettera aperta di Massimo d’Azeglio al Prof. Francesco Orioli del 28 marzo 1847;
una “Lettera politica al Cav. Panizzi Bibliotecario del Museo Britannico” in francese di Massimo d’Azeglio (1856);
un manoscritto dal titolo “Proposta d’un Programma per l’opinione Moderata Progressista Italiana” di Massimo d’Azeglio (1847);
un manoscritto dal titolo “Sulla Protesta pel caso di Ferrara” di Massimo d’Azeglio (11 ago. 1847);
un manoscritto di Massimo d’Azeglio dal titolo “Sur les moyens propres a Préparer la reconstitution de l’Italie” (1855);
un manoscritto di Massimo d’Azeglio dal titolo “La politique et le droit chrétien au poin de vue de la question italienne par Massimo d’Azeglio. 1859”;
alcuni estratti di storia universale dal titolo “Abrégé de l’Histoire Universelle 1.er Cahier” (senza data);
Per quanto riguarda la serie degli “Stampati” si trovano vari estratti ed articoli di giornali europei, notificazioni e sentenze per un periodo che va dal 1825 al 1865. Tra questi documenti si segnala:
un articolo del giornale di Londra “Morning Chronicle” del 3 aprile 1852 relativo al asserzioni del Conte Solaro della Margherita su Massimo d’Azeglio;
un ritaglio del giornale di Firenze “Lo Statuto” del 4 giugno 1849, inviato a Massimo d’Azeglio da Salvatore Pes di Villamarina, in cui si fa una critica negativa al partito Repubblicano in Piemonte;
un ritaglio del girnale “Indipendance” del 16 feb. 1856, allegato alla lettera N.561/78 (19) inviata da Giacinto Provana di Collegno a Massimo d’Azeglio, relativo alla posizione del Piemonte nella Conferenza di Pace del 1856;
una notificazione del Cardinale Pasquale Gizzi, Legato Apostolico di Forlì e provincia, (datata Forlì, 13 nov. 1845), relativa ai disordini accaduti a Rimini per il timore di una mancanza di cereali. Nella Notificazione si esorta e si avverte ad astenersi da ogni altro disordine, giacchè i colpevoli di ciò sarebbero stati severamente puniti dalla Legge;
una Sentenza della Commissione Speciale Straordinaria Mista contro Giacomo Bagioli (detto Barnè), Francessco Casadio (detto il Monco), Giovanni Baldoni (detto Flemma), imputati per l’omicidio del Brigadiere dei Carabinieri Antonio Aparapani (14 gen. 1845) e per l’omicidio del soldato svizzero Carlo Adolf (30 gen. 1845) a Ravenna. Il giorno 9 aprile 1845 venne eseguita la condanna a morte per decapitazione di Giacomo Bagioli e Francesco Casadio, mentre fu carcerato Giovanni Baldoni (sentenza datata Ravenna, 31 mar. 1845);
una Sentenza della Commissione Speciale Straordinaria Mista contro Pietro Minguzzi (facchino), Giovanni Majoli (facchino), Francesco Vandini (facchino), Luigi Vandini (guardiano di campagna), Pasquale Vandini (vetturino), imputati per l’omicidio del Carabiniere Paolo Bersani (12 feb. 1844) avvenuto a Ravenna. Furono condannati al remo perpetuo nella galera per vent’anni (sentenza datata Ravenna, 14 apr. 1845).
Storia archivistica:
Massimo Taparelli d’Azeglio (Torino, 24 ott. 1798 – Torino, 15 gen. 1866) appartenne alla nobile famiglia dei Taparelli d’Azeglio e di Lagnasco: il padre, marchese Cesare, uno dei più cospicui rappresentanti del cattolicesimo subalpino della Restaurazione, e la madre Cristina Morozzo di Bianzè. La sua formazione letteraria si compì da autodidatta in epoca tarda: infatti fin dall’età di 16 anni fu nominato Sottotenente nel “Piemonte Reale Cavalleria”. In questa occasione si trovò ad essere superiore a soldati reduci dalle campagne napoleoniche secondo i principi ristabiliti da Vittorio Emanuele I, in base ai quali i giovinetti e gli anziani di nobili famiglie andavano prima, mentre venivano retrocessi i veterani di Napoleone, quasi sempre ammirevoli per il valore personale. Il carattere di d’Azeglio in questa occasione già si era formato come avversatore dei privilegi aristocratici ai quali teneva tanto la sua nobile parentela, infatti egli sembrava quasi vergognarsi della propria fortuna, cercando di nascondere la sua nobiltà. Passò poi dalla Cavalleria alle Milizie Provinciali, ebbe tempo di studiare e farsi una formazione sulle lettere e sulle arti, in un periodo in cui stavano diventando sempre più attive le sette segrete, anche se egli ne restò lontano pur desiderando la cacciata degli stranieri e l’abolizione dei privilegi.Nel 1820 decise di recarsi a Roma per apprendere e coltivare la pittura, sprezzando i pregiudizi sociali che condannavano tale vocazione per un nobile. Anche a Roma giunsero le notizie dei moti di Napoli e di Torino del 1820 – 1821, ed egli avrebbe voluto andare a combattere per Napoli, ma venne persuaso dal Segretario della Legazione a Napoli, Solaro della Margarita, suo amico, a rimanere nella capitale, dove il d’Azeglio continuò ad occuparsi si pittura per dieci anni. Dopo la morte del padre, nel 1831 si stabilì a Milano e si dedicò alla letteratura, sposando la figlia Giulia di Alessandro Manzoni. In questo periodo pubblicò a Milano nel 1833 il romanzo “Ettore Fieramosca o la Disfida di Barletta”, realizzando un grandissimo successo. Incoraggiato da ciò, produsse un secondo romanzo il “Niccolò dei Lapi”: con tale produzione letteraria il d’Azeglio veniva considerato tra gli educatori dei sentimenti nazionali, attraverso opere che potevano penetrare piuttosto facilmente dappertutto, perché scritte in forma blanda e quindi non potevano colpire subito i censori, abituati a respingere opere scritte in stile ben diverso.
Nel 1844 si può dire che il d’Azeglio entri nella vita della politica italiana: gli venne offerta la direzione del movimento liberale in Romagna, che accettò. Alla fine di questo viaggio politico per varie città della zona, ottenne a Torino un’udienza da Carlo Alberto (circa intorno al 12 ottobre 1845). In questo periodo scoppiò il moto di Rimini e il d’Azeglio concepì l’opuscolo “Degli ultimi casi di Romagna” con il quale iniziò la sua brillante carriera di pubblicista (il libro venne stampato nel marzo del 1846 in Toscana). In esso venivano espresse con linguaggio facile e scorrevole tutte le osservazioni del d’Azeglio sulle condizioni dello Stato Pontificio e dell’Italia, e il programma politico che sosteneva. Ma il governo della Toscana, allarmato, ordinò all’autore di allontanarsi dal Granducato, così il d’Azeglio fu costretto a recarsi in Piemonte, con l’immagine del perseguitato, pur essendo acclamato con gran simpatia in tutte le città toscane. Dopo varie perigrinazioni per Torino, Lucca, Genova, nel 1847 giunse a Roma, dove più volte espresse la sua grande fiducia per il Papa Pio IX, divenendo l’anima e la voce del movimento moderato. Presto ebbe inizio la guerra all’Austria alla quale egli partecipò come Aiutante di campo del Generale Piemontese Giovanni Durando; si battè e venne ferito il 10 giugno 1848 a Monte Berico nell’eroica difesa di Vicenza. Terminata la guerra e tornato a Firenze, prese parte attivamente alla vita politica toscana scrivendo nel giornale “La Patria”. Tornò quindi a Torinio, e il 10 dic. 1848 gli fu offerta la Presidenza del Consiglio dei Minstri, che lui rifiutò ed accettò invece il Gioberti. In seguito dal 7 maggio 1849 al 4 novembre 1852 il d’Azzeglio si trovò a presiedere il Ministero. Durante questo periodo del suo Ministero si attuarono il riordinamento dell’esercito, il rinvigorimento delle finanze, vennero migliorate le relazioni economiche del Piemonte specialmente con le Potenze Occidentali. Con lui lavorarono Alfonso La Marmora e Camillo Cavour. Sotto il suo Ministero si curarono i difficili problemi dell’emigrazione italiana, iniziarono anche nuovi rapporti fra lo Stato e la Chiesa. Il 20 ottobre del 1853 d’Azeglio, lasciata la Camera, entrò in Senato e insieme alla politica riprese la sua attività artistica di pittore, divenendo anche il 28 marzo 1855 Direttore della Regia Galleria di Torino.
Trascorse tre anni di vita tranquilla tra Torino e la sua villetta di Cannero sul Lago Maggiore. Nella documentazione della “Raccolta Azegliana” si ha una memoria prodotta in questo periodo e più precisamente nel 1856, dal titolo “Memorandum confidenziale intorno al viaggio che il Re Vittorio Emanuele nell’anno 1856 stava per fare in Francia e in Inghilterra”, manoscritta dal d’Azeglio in francese.
Nel 1859 il d’Azeglio tornò alla politica militante: si recò, infatti a Londra a portare il collare dell’Annunziata al Principe di Galles, quindi andò come Plenipotenziario sardo a Parigi e poi ancora a Londra. Di questo periodo si trova nel carteggio della “Raccolta Azegliana” un Decreto della Regina di Spagna Isabella II per il conferimento a Massimo d’Azeglio della dignità di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine di Carlo III di Spagna (datato Madrid, 25 set. 1859).
Nel 1860 Cavour gli offrì il posto di Governatore di Milano ed egli accettò (16 gen. 1860). Si trovò però a disagio non approvando la politica di Cavour specialmente rispetto al Mezzogiorno, preferì quindi lasciare il Governo. Come nella questione meridionale, così nella questione romana egli prese posizione contraria alle aspirazioni generali del paese. Per le discussioni sul trasporto della capitale a Firenze, fu accusato di municipalismo piemontese.
E’ interessante segnalare un documento presente nel carteggio della “Raccolta Azegliana” che testimonia in modo diretto la situazione politica in Italia nel 1860: si tratta di una lettera (datata Torino, 15 marzo 1860) del Ministero di Grazia e Giustizia ed Affari Ecclesiastici diretta agli Avvocati Fiscali Generali riguardante la Bolla di Scomunica della “Corte di Roma” contro il Re e i suoi Ministri per l’annessione delle Romagne.
Nel principio del 1863 egli cominciò a stendere i suoi “Ricordi”, quando morì a Cannero il 15 gen. 1866 e questa autobiografia, tra le più caratteristiche del Risorgimento, non potè essere compiuta.
All’interno del carteggio della “Raccolta Azegliana” vi è una grande documentazione relativa alla condizione degli Ebrei:
Redazione e revisione:
- Pizzo Marco, 2005/04/16, compilazione
- Pizzo Marco, 2016/09/19, aggiornamento