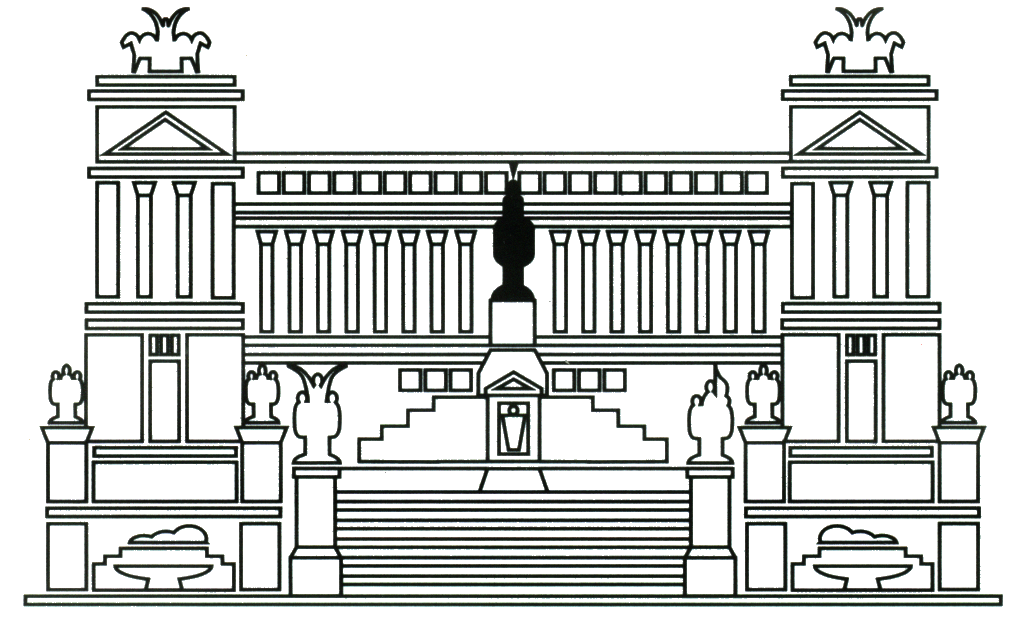Titolo originale:
Fondo BixioTipologia:
fondoData:
(s.d.)Consistenza:
[non specificata]Descrizione:
Il fondo archivistico di Nino Bixio conservato presso il Museo Centrale del Risorgimento di Roma è costituito dalla busta 83 (consistente in 72 fascicoli) e dal manoscritto 41. La documentazione raccolta nella busta 83 presenta una diversificata tipologia archivistica essendo costituita da cause e processi, memorie, lettere, minute, relazioni, manoscritti, stampati, ordini del giorno, telegrammi, appunti, note, uno spartitimusicalimanoscritti, carta topografica e l’arco cronologico compreso da questa documentazione va dal 1802 al 1903.E’ opportuno segnalare in maniera analitica la composizione di questo fondo, in seguito all’analisi svolta nel corso della schedatura presso il Museo Centrale del Risorgimento, considerando dapprima il materiale conservato nella busta 83 e di seguito il manoscritto 41, la cui documentazione va dal 1859 al 1907.
B.83 Fasc.1: “Causa Tagliavia e Comp.i: fatti del processo Tagliavia e Compagni detto impropriamente dè ‘Pugnalatori’ con gli argomenti della maggioranza per la definizione della causa”: si tratta di una Memoria della seconda metà del XIX sec.
Fasc.2: “Commissione temporanea istituita nel processo de’ 15 Maggio 1848. Schiarimenti sulle operazioni della Commissione temporanea nella istituzione del Processo per la catastrofe del giorno 15 Maggio 1848”: si tratta di una memoria del 2° quarto del XIX sec.
Fasc.3: “Camera de’ Pari: diverse nomine de’ Pari. 1°: Pari nominati cn decreto del 13 maggio 1848 – 2°: Pari nominati con decreto del 26 giugno 1848 – 3°: Pari nominati con decreto del 9 luglio 1848 – 4°: Estratto dei Pari Ecclesiastici”: si tratta di un elenco dei Pari del 1848.
Fasc.4: “Napoli [Regno di Napoli]: Stato politico delle Provincie Continentali nelle settimane precedenti al 7, 14, 21, 28 agosto 1848”: si tratta di una memoria dal titolo “Stato Politico delle Provincie Continentali all’epoca della scorsa settimana: Terra di Lavoro, Principato Citeriore, Principato Ulteriore, Capitanata, Terra di Bari, Terra d’Otranto, Contado di Molise, Abruzzo Citeriore, Abruzzo Ultra 1°, Abruzzo Ultra 2°, Basilicata, Calabria Citeriore, Calabria Ultra 1^, Calabrai Ultra 2^”.
Fasc.5: “Lettera d’ufficio (modulo stampato) delle Presidenze di Roma e Comarca (Governo della Repubblica Romana) con cui si annunzia al Dr. Andrea Pasquali la nomina di Consigliere Municipale. Roma, 25 aprile 1849, firmato Livio Mariani”.
Fasc.6: “Lettera d’ufficio con cui il Triumvirato della Repubblica Romana nomina il Dr. Andrea Pasquali Soprintendente Generale degli Ospedali di Roma con l’assegno di scudi settanta. Li 10 Aprile 1849. Firmato A. Saffi”.
Fasc.7: “Lettera d’ufficio del Ministero dell’Interno del Governo della Repubblica Romana, con la quale si nomina il Dr. Andrea Pasquali Membro delal Commissione Organica della Guardia Civica. Li 4 Gennaio 1849. Firmato C. Armellini”.
Fasc.8: “Ottolini Luigi. ‘Il 24 Giugno 1859’. Episodio della Seconda guerra dell’Indipendenza Italiana”: si tratta di un manoscritto con tavole miniate figurate, realizzate a matita e inchiostro acquarellato su carta.
Fasc.9: “Ferdinando di Savoia, Duca di Genova. Lettera a Felice Cerruti. Si rivolge al Cerruti perché preghi Pietro Giuria di comporre un inno da mettere in musica e fare cantare dai soldati. Vi è unito il fac-simile fotografico in 3 carte e un cartoncino con la trascrizione a stampa della lettera”, si tratta della lettera in cui Ferdinando di Savoia prega Felice Cerruti (sottotenente allo Stato Maggiore della 4^ Divisione) di volersi far fare dal poeta Pietro Giuria un inno patriottico da poter far cantare ai suoi soldati e chiede che sia esclusa la parola di “barbaro o altre parole ingiuriose” e conclude dicendo “giacchè combattendo da soldati, abbiamo, come tali, imparato a stimarci” (Novara, 20.10.1848).
Fasc.10: “…Poldo. Lettera al Sig.r D. Palo Pieroni. Gli dà ampi ragguagli intorno al fatto d’armi del 29 maggio, avvenuto fra Toscani e Austriaci”: la lettera è datata Brescia, 8.6.1848. Il mittente si firma “Poldo”.
Fasc.11: “Massimo Camillo, Tenente Colonnello della Guardia Civica, Battaglione di Arsoli. ‘Ordine del giorno 15 agosto 1848’. Due copie a stampa di cui una con note autografe”.
Seguono alcune lettere analizzate in particolare relative al carteggio di Benedetto Musolino con il Conte Giuseppe Ricciardi presenti dal fasc.12 fino al fasc.53 complessivamente.
Fasc.12: “Musolino Benedetto: lettera al Conte Giuseppe Ricciardi. Scrive di aver rilevato dall’ <Indipendence> belga che ‘Sirtori ha pubblicato in Genova una specie di programma politico relativamente alle questioni italiane, ch’egli vorrebbe isolare dalla italiana, lasciando ad un’assemblea nazionale il diritto di pronunziarsi sulla forma di governo da sostituirsi all’attuale borbonico’. Il Musolino combatte quest’idea. Tocca quindi della ‘polemica George Sand, Manin ed altri’ e dice ‘Io ne arrossisco per i nostri compatrioti’” (Parigi, 4.4.1857).
Fasc.13: “Musolino Benedetto: lettera al Conte Giuseppe Ricciardi. Esprime dolore per la tragica fine di Pisacane, e entra in alcuni particolari relativi alla fallita spedizione di Sapri. E poiché il Ricciardi aveva scritto al Musolino ‘Il governo del Piemonte è il solo governo d’Italia non disonesto’ egli fa in proposito qualche riserva esprimendo il suo modo di pensare a questo riguardo” (Parigi, 11.7.1857).
Fasc.14: “Musolino Benedetto: lettera al Conte Giuseppe Ricciardi. Scrive nuovamente intorno alla fallita spedizione di Sapri della quale ha ricevuto notizie dapiù parti, e ripete che fu una impresa sconsigliata, ‘I buoni consigli non mancarono…e tutto accadde come fu previsto; ma l’altro male che fa il mazzinianismo è questo: toglie anche l’ingegno, anzi il senso comune a quelli che si arruolarono in tale partito’” (Parigi, 22.7.1857).
Fasc.15: “Musolino Benedetto: lettera al Conte Giuseppe Ricciardi. Dice di aver conferito col capocomico Dondini per indurlo a rappresentare le produzioni drammatiche del Ricciardi, ma questa rappresentazione non può aver luogo né in Italia, né in Francia per le allusioni politiche contenute in quei drammi. Gli fa sapere d’aver venduta qualche copia delle opere del Ricciardi, e gli dà notizie di sé dicendogli che attualmente, essendo la morta stagione per le lezioni, si è rimesso a fare il copista, e lavora otto ore al giorno per guadagnare 36 o 40 soldi” (Parigi, 2.9.1857).
Fasc.16: “Musolino Benedetto: lettera al Conte Giuseppe Ricciardi. Dopo aver trattenuto il Ricciardi intorno a cose private, entrando nel terreno politico, dice: ‘Secondo me, seguire la politica del Piemonte è fare la causa dell’Austria’. Prosegue quindi dimostrando la verità di tale sua asserzione. Seguono alcuni brevi giudizi rigurdo a Montanelli e ad altri patrioti” (Parigi, 8.10.1957).
Fasc.17: “Musolino Benedetto: lettera al Conte Giuseppe Ricciardi. Espone alcuni suoi giudizi su Garibaldi e i suoi precedenti politici. Parla quindi di La Farina intorno al quale parimenti esprime la propria opinione” (Parigi, 17.3.1858).
Fasc.18: “Musolino Benedetto: lettera al Conte Giuseppe Ricciardi. Scrive intorno ad una protesta da farsi contro il governo del Borbone nel Regno di Napoli. Vorrebbe che la protesta fosse quanto mai energica e vibrata contro il Borbone che ‘inasprisce di giorno in giorno nel modo più bestiale’. Passando ad altri argomenti, assicura il Ricciardi che la Ristori [l’attrice Adelaide Ristori] non gli è nulla ostile, e che ‘è una buonissima donna’” (Parigi, 2.12.1858).
Fasc.19: “Musolino Benedetto: lettera al Conte Giuseppe Ricciardi. Esprime il suo modo di vedere intorno alle speranze d’Italia e alla situazione anteriore alla seconda guerra per l’indipendenza” (Parigi, 16.3.1859).
Fasc.20: “Musolino Benedetto: lettera al Conte Giuseppe Ricciardi. Non crede possa scoppiare la guerra, e se anche dovese aver luogo, non ne verrebbero, secondo il Musolino, i vantaggi generalmente sperati; ne espone i motivi” (Parigi, 16.4.1859).
Fasc.21: “Musolino Benedetto: lettera al Conte Giuseppe Ricciardi. ‘Non bisogna’, scrive ‘farsi illusione sugli avvenimenti che si preparano. La Francia ci darà forse la indipendenza, se sarà vittoriosa, ma quanto a unità e forse anche a libertà, c’è molta riserva a fare’. Non ha offerto i suoi servigi al Piemonte perché pensa che il paese in cui egli può essere più utile è il Napoletano” (Parigi, 26.5.1859).
Fasc.22: “Musolino Benedetto: lettera al Conte Giuseppe Ricciardi in cui accenna a un Memorandum da lui indirizzato al Re di Sardegna Vittorio Emanuele e a una lettera al Conte di Cavour sulla questione italiana, dicendo che bisogna agire in senso piemontese, chiedere cioè aiuto al governo piemontese e servirsene per dare la corona di tutta Italia a Vittorio Emanuele. Segue, dopo la firma della lettera, un P.S. in cui parla delle notizie avute dall’Italia e dei mezzi per raggiungere l’unità itliana, basandosi sul Piemonte” (Parigi, 4.7.1859).
Fasc.23: “Musolino Benedetto: lettera al Conte Giuseppe Ricciardi in cui deplora, analizzandola, la pace di Villafranca e l’architettata Confederazione italiana, ritenendo il Piemonte, Vittorio Emanuele e Cavour complici di Napoleone. Consiglia di parlare a quattr’occhi al Conte di Cavour, il quale conservando sempre la fiducia del Re, lo può persuadere a mettere a soqquadro il Regno delle Due Sicilie prima che la Confederazione sia accettata e sanzionata. ‘Se si riesce, dopo aver messo giù il Borbone, Napoli si metterà alla testa della rivoluzione italiana per costituire una monarchia unitaria con alla testa Vittorio Emanuele” (Parigi, 16.7.1859).
Fasc.24: “Musolino Benedetto: lettera al Conte Giuseppe Ricciardi. Dopo aver parlato a lungo di affari privati, fa un breve cenno alla politica per dichiararsi niente affatto contento della situazione, ritenendo Cavour un grande imbroglione. Alla lettera è unito un P.S. nel quale espone osservazioni e presagi riguardo una impresa per suscitare la rivoluzione nel Napolitano e in Sicilia (La spedizione dei Mille)” (Parigi, 29.4.1860).
Fasc.25: “Musolino Benedetto: lettera al Conte Giuseppe Ricciardi. Dopo aver parlato di affari privati, si occupa della spedizione di Garibaldi in Sicilia, rallegrandosi della riuscita e cercando di giustificare le previsioni pessimiste che nella lettera del 29 aprile aveva manifestato” (Parigi, 13.6.1860).
Fasc.26: “Musolino Benedetto: lettera al Conte Giuseppe Ricciardi. Lo informa che Rattazzi ha ricevuto la lettera accennata dal Ricciardi, ‘ma pare che on abbia creduto necessario darne lettura alla Camera’” (Parigi, 27.1.1862).
Fasc.27: “Musolino Benedetto: lettera al Conte Giuseppe Ricciardi. Parla del trasferimento della Capitale a Firenze” (Torino, 30.1.1863).
Fasc.28: “Musolino Benedetto: lettera al Conte Giuseppe Ricciardi. Accenna ad accuse contro Nicotera ripetute da giornali francesi, e dice: ‘Come storico imparziale voi avete una fonte purissima alal quale attingere le notizie vere. Il fatto di Sapri fu oggetto di un pubblico e solenne giudizio in Salerno. Nell’archivio di quella ex Gran Corte Criminale esiste il processo compilato, discusso e giudicato in quell’occasione… Procurate di averne copia’” (Reggio, 19.8.1866).
Fasc.29: “Musolino Benedetto: lettera al Conte Giuseppe Ricciardi. Gli raccomanda che nelle ‘Storie documentate’ intorno alle quali lavorava il Ricciardi, narri con tutti i suoi particolari la dissoluzione del campo di Campoteren ove egli (il Musolino) andò inutilmente per prendere il comando delle milizie” (Firenze, 4.2.1869).
Fasc.30: “Musolino Benedetto: lettera al Conte Giuseppe Ricciardi. Accenna a un fatto nel quale La Cecilia si è compromesso, e sembra sia stato arrestato nel Calvados. Ritiene inutile ogni pratica in suo favore” (Firenze, 19.6.1871).
Fasc.31: “Musolino Benedetto: lettera al Conte Giuseppe Ricciardi. Parla di affari privari e del so prossimo viaggio a Roma” (Firenze, s.d.).
Fasc.32: “Musolino Benedetto: lettera al Conte Giuseppe Ricciardi. Si congratula per il nuovo lavoro del Conte Ricciardi ‘La Repubblica di S. Marino e l’Italia’ e gli fa qualche critica osservazione in proposito. Circa poi la qestione sulla miglior forma di governo dice che dev’essere proposta in quest’altro modo: ‘Quali sono le istituzioni sociai più prprie ad assicurare il benessere individuale e la generale prosperità?’” (Roma, 4.11.1871).
Fasc.33: “Musolino Benedetto: lettera al Conte Giuseppe Ricciardi. Lo assicura di aver consegnato al Miceli il manifesto da lu speditogli, e di averne avuta la promessa di prossima pubblicazione sulla Riforma” (Roma, 14.2.1872).
Fasc.34: “Musolino Benedetto: lettera al Conte Giuseppe Ricciardi. Gli promette che prorogato il Parlamento manterrà la promessa fattagli di visitarlo. Nel corso dell’estate sarà senza dubbio a Napoli” (Roma, 12.6.1872).
Fasc.35: “Musolino Benedetto: lettera al Conte Giuseppe Ricciardi. Spedisce un numero della Riforma nel quale è riportato un articoletto del Ricciardi. ‘Finalmente’ soggiunge ‘io ho pensato di presentare la vostra proposta anche al Suffragio Universale, giornale messo su espressamente dall’associazione intesa a promuovere siffatta riforma’” (Roma, 4.10.1872).
Fasc.36: “Musolino Benedetto: lettera al Conte Giuseppe Ricciardi. Gli annunzia che la Riforma accetta il suo manoscritto, e che incomincerà a pubblicarlo nei primi giorni del prossimo gennaio” (Roma, 7.12.1872).
Fasc.37: “Musolino Benedetto: lettera al Conte Giuseppe Ricciardi. Gli scrive che la Riforma annunziò da gran empo il lavoro del Ricciardi” (Roma, 9.1.1873).
Fasc.38: “Musolino Benedetto: lettera al Conte Giuseppe Ricciardi. Lo avverte di aver già consegnato alla Riforma il suo lavoro sulla tassa unica. Se ancora non fu pubblicato non dipese da malvolere di Crispi, ma dal fatto che l’incaricato speciale per la parte finanziaria non aveva ancora potuto leggere quel lavoro per darne il suo giudizio” (Roma, 15.2.1873).
Fasc.39: “Musolino Benedetto: lettera al Conte Giuseppe Ricciardi. Lo informa che la pubblicazione del lavoro indicato nella lettera precedente è stata ritardata per impegni assunti precedentemente dalla Riforma a favore di altre materie. Aggiunge che h aconsegnato a Crispi il libro contenente i documenti e gli atti relativi all’incarico di scrivere un articolo da pubblicare nella Riforma” (Roma, 10.3.1873).
Fasc.40: “Musolino Benedetto: lettera al Conte Giuseppe Ricciardi. Giustifica il ritardo posto nell’inviargli il resoconto ufficiale della Esposizione finanziaria fatta dal Ministro Quintino Sella” (Roma, 29.3.1873).
Fasc.41: “Musolino Benedetto: lettera al Conte Giuseppe Ricciardi. Gli fa sapere che della Redazione della Riforma non conosce che il Crispi, il quale è ora lontano da Roma, quindi non può indirizzarsi ad altri per la pubblicazione dell’articolo sulle Economie. Passando ad altro dice che Pio IX commise, è vero, delle grandi colpe, ma non è men vero che con i suoi errori contribuì alla rigenerazione italiana. Parla infine della pubblicazione della Storia documentata della sollevazione Calabra dle 1848 ” (Roma, 3.5.1873).
Fasc.42: “Musolino Benedetto: lettera al Conte Giuseppe Ricciardi. Lo assicura di essere ‘continuo martello all’orecchio di Crispi’ per la pubblicazione dell’articolo sulle Economie, ma che Crispi si scusa col dire che Seismit-Doda, il quale è incricato della parte finanziaria della Riforma, non ha ancora dato il parere. Gli annuncia la istituzione delel cartoline postali a 10 cm.” (Roma, 3.6.1873).
Fasc.54: “Lettera di A Elia a [Telesforo Sarti ?]. Risponde a una lettera di congratulazioni per la giustizia che gli è stata resa dalle oneste persone del suo Collegio contro ‘le vili insinuazioni di esseri irresponsabili’ che avevano posto in dubbio ch’egli fosse stato ferito a Catalatafimi mentre copriva col suo corpo il Gen.le Garibaldi.” (Roma, 11.6.1886).
Fasc.55: “Lettera di Aurelio Saffi a Telesforo Sarti. Parla del nuovo periodico ‘L’Italia’ che il Sarti si proponeva di fondare ed esprime alcuni suoi pensieri sull’irredentismo” (San Varano, 21.9.1879).
Fasc.56: Telegramma di Terenzio Mamiani a Telesforo Sarti, col quale il Mamiani dà un giudizio favorevole sul Cadolini candidato alla deputazione. Testo del telegramma: “Conosco Cadolini perfetto ones’uomo specchiato patriota degno cento volte essere Deputato. Terenzio Mamiani” (Roma, ultimo quarto del XIX sec.).
Fasc.57: “Anonimo: lettera a Madame Hippolito Serra Livizzani. In questa lettera, riguardante affari privati, sono inserite notizie relative al soggiorno di Murat in Roma e alle pratiche per il <Concordato>” (Roma, 24.4.1802).
Fasc.58: “Anonimo: appunti relativi al risarcimento preteso dal Gorverno Austriaco per i danni avuti durante la Repubblica Romana nel 1849” (2° quarto del XIX sec.).
Fasc.59: Fascicolo contenente documentazione in copia, costituito in occasione delle “Nozze Valmarana – Nusi”. In particolare: 1) lettera a stampa di Guido Piovene allo sposo Angelo (?), datata Vicenza, 20.5.1897, relativa al dono dello scritto di Daniele Manin e Nicolò Tommaseo del 1848 di seguito allegato; 2) lettera a stampa di Giambattista Bassi al Senatore Fedele Lampertico, datata S. Margherita presso Udine, 23.3.1874, relativa allo scritto di Daniele Manin e Nicolò Tommaseo del 1848 di seguito allegato; 3) lettera a stampa del Senatore Fedele Lampertico al Bibliotecario Civico di Vicenza D. Andrea Capparozzo, datata Vicenza, 26.3.1874, in cui si comunica il dono dello scritto di Daniele Manin e Nicolà Tommaseo del 1848 di seguito allegato; 4) copia di lettera di Daniele Manin e Nicolò Tommaseo, datata Vicenza, 21.5.1848, in cui annunciano al Governo Provvisorio della Repubblica di Venezia di aver respinto da Vicenza l’assalto degli Austriaci senza il soccorso del Gen. Durando.
Fasc.60: “Zamboni Filippo: lettere a Domenico Ciampoli. In queste due lettere lo Zamboni invita il prof. Ciampoli a rivendicargli la fama che gli spetterebbe per la parte avuta nella prima guerra dell’indipendenza italiana (Battaglione Universitario” (s.d.).
Fasc.61: “Note e postille marginali apposte da Riboli Timoteo all’opera di Pietro Ripari ‘Storia medica della grave ferita toccata in Aspromonte il giorno 22 agosto 1862’. Esp. Biblioteca Nazionale V.E.” (s.d.).
Fasc.62: “Appendice. Atti e disposizioni emanati dall’Autorità Militare francese dopo l’ingresso in Roma, e da i Commissari Straordinari pontifici della medesima Autorità nominati per la ripristinazione del Governo della S. Sede” (2° quarto del XIX sec.).
Fasc.63: Manoscritto “Grido della Gioventù Romagnola. Coro popolare a sole voci posto in musica dal M.[aestr]o E. Pettinati in Faenza […] 1847”. Si tratta di uno spartito musicale manoscritto del 2° quarto del XIX sec.
Fasc.64 Manoscritto “L’Italia. Marcia di Giovanni Potenza, Sergente Musica nel 47° Fanteria”. Si tratta di uno spartito musicale manoscritto dal titolo “L’Italia” (Peschiera, 7.2.1890).
Fasc.65: “Sommario manoscritto. Varie parlate dle Prete Claudio Della Valle estratte ad Varbum dal Monitore di Roma, esistente nella Biblioteca Casanatense” (s.d.).
Fasc.66: “Bixio Nino: Nota autografa sulla carta topografica per la presa di Roma (1870). Lo Stato Maggiore, Divisione II” (Roma, 21.9.1870).
Fasc.67: “Processo per la rivoluzione del 15 Maggio 1848 con le dichiarazioni dei Deputati De Cesare, Cacace Camillo, Capocci, Gabriele Pepe, Ferdinando De Luca, Cacace Teodorico, Aceto, Baldacchini, Amodio” (2° quarto del XIX sec.).
Fasc.68: “Fac – simile della minuta della protesta scritta da P.S. Mancini per incarico avuto dalla Camera dei Deputati napoletana quando questa fu violentemnte sciolta nelle sale di Monteoliveto” (Napoli, 15.5.1848).
Fasc.69: “Relazione (‘Giornale’) dei fatti avvenuti in Napoli il 12 maggio 1848 con la formula di giuramento dei Deputati napoletani” (Napoli, 12.5.1848).
Fasc.70: “Notamento de’ Deputati presenti nella Camera il dì 15 Maggio” (Napoli, 15.5.1848).
Fasc.71: “Appunti sulla cospirazione de’ Deputati prima del 15 maggio in Napoli 1848” (Napoli, 2° quarto del XIX sec.).
Fasc.72: “Diversi frammenti dle Processo contro Pica. 1848. Con appunti autografi del Pica e di altri implicati nel Processo del 15 maggio” (2° quarto del XIX sec.).
MANOSCRITTO 41
E’ la copia del Diario e delle lettere di Nino Bixio intorno alla spedizione dei Mille e altri documenti. Il frontespizio interno è intitolato: “Diario di Nino Bixio sui preprativi per l’imbarco della Prima Spedizione. Dalla partenza da Quarto il 5 maggio 1860, insino alla presa di Palermo. Dal N.1 al N.62”. La cronologia esatta va dall’aprile 1860 al 27 ottobre 1907.
In particolare all’interno del volume manoscritto si trova:
cc.1-15: “Memorie nell’aprile – maggio 1860”.
cc.15-37: “Lettere di Nino Bixio inedite in parte”, (4 giu. 1859 – 9 apr. 1856) dirette alal moglie e al Gen. Turr.
cc.37-47: “Frammenti di memorie sulle campagne 1848-1849 ricopiati da Nino Bixio dal taccuino avuto indono da Goffredo Mameli. Ricopiati il 28 marzo 1865 in Alessandria”.
cc.48-51: “Lettere di Garibaldi a Bixio” (15 gen. 1861 – 27 set. 1877). L’ultima lettera è relativa alla morte del Bixio.
cc.52-58: lettere a Nino Bixio da parte di Lorenzo Valerio (20 ott. 1859); Carmelo Agnetta (16 ott. 1861); Giovanni Tabacchi (17 mar. 1862); Enrico della Rocca (s.d.); Abba (20 gen. 1874), lettera relativa alla morte di Nino Bixio; Cibrario (diploma di nomina di Bixio a Cav. dii Gran Croce dell’Ordine della Corona d’Italia, 23 gen. 1870); Ministro della Guerra, Giuseppe Govone (9 ago. 1870); Rosolino Pilo (24 feb. 1860).
c.58: comunicato di Nino Bixio relativo all’episodio di Aspromonte (Estratto dalla Gazzetta di Torino del 1862).
c.59: Indice.
cc.60-62: “Trascrizione di due foglietti autografi di Nino Bixio prestatimi a questo intento dal Sig.r Col.o Francesco Scalvo a mezzo del Comm. Alberto Dallolio. F. Cantoni 27.10.1907”.
Storia archivistica:
Genova, 2 ott. 1821 – Atchin (Sumatra) 16 dic. 1873Ebbe una infanzia molto disordinata a causa della prematura morte della madre: impetuoso e ribelle fu fatto imbarcare dal padre come mozzo nel 1834 su una nave mercantile e nel novembre del 1837 fu fatto arruolare di forza come “volontario” nella Marina Militare Sarda, dove vi rimase quasi sette anni, raggiungendo nel 1841 il grado di Allievo Pilota. Nel 1846 dopo varie avventure nel mare di Sumatra, il Bixio fu costretto a tornare con mezzi di fortuna in Europa. Inizia in questo periodo l’impegno politico, accettando di farsi propagatore nel Regno Sardo delle idee di Mazzini e diffusore della ristampa della sua lettera a Carlo Alberto del 1831.
Nella Genova del 1847 egli strinse rapporti con gli elementi repubblicani della città e si avvicinò a G. Mameli. Fece anche propaganda d’ispirazione mazziniana negli ambienti studenteschi, ma finì per accettare l’alleanza con i moderati e l’inserimento nel Comitato dell’ordine, composto da rappresentanti di tutte le tendenze liberali. Bixio si rivelò subito come uomo di azione, primo nei cortei, nelle manifestazioni e nei tumulti e alle prime avvisaglie della guerra si arruolò come volontario. Infatti fu Sottotenente nel 1848 sotto il diretto comando di Mameli nella Legione Torres, composta da Lombarti e Veneti, combattendo nel Bresciano. Quindi passò nella Legione mantovana di A. Longoni, nella Legione bolognese di L. Zambeccari, rimanendo poi aggregato alle truppe pontificie. Ben presto raggiunse in Romagna Garibaldi e divenne suo Ufficiale di ordinanza e con lui ispezionò i confini napoletani, attraversando le Marche. Ferito nel combattimento del 3 giugno 1849 e curato in un ospedale romano, il Bixio potè lasciare Roma, occupata dai Francesi, solo nel novembre del 1849. Convinto di possibilità di riscossa e per questo spronato da Giuseppe Mazzini, che incontrò a Londra nel 1850, riprese a svolgere attività organizzativa repubblicana: nel 1851 era nel consiglio di direzione dell’Italia e popolo e si trasferì a Torino per proseguire la segreta opera di propaganda mazziniana. Nel 1853 riuscì a costruire una nave “Goffredo Mameli” con cui partì il 28 nov. 1855 per l’Australia per ritornare poi a Genova nel settembre del 1857. Ritornato in Italia, Nino Bixio si inserì, insieme a Bertani e Medici, nel movimento che abbandonava le pregiudiziali mazziniane per la collaborazione con la monarchia sabauda e con il governo di Cavour, in vista della guerra contro l’Austria. Iniziò in questo periodo ad insistere sulla necessità della dittatura piemontese e della alleanza con Napoleone III, cercando di esercitare nello stesso tempo pressioni sul governo di Torino. Quando il 26 aprile 1859 scoppiò la guerra con l’Austria, Nino Bixio era già a Savigliano, centro di raccolta dei volontari: maggiore nei Cacciatori delle Alpi, combattè con Garibaldi in Valtellina e a Villafranca, seguendolo poi nell’Italia centrale, dove era urgente il problema di organizzare l’esercito dei governi provvisori, sorti dalla rivoluzione. Con Bertani, Medici, Crispi, e Pilo, cominciò a interessarsi ad una iniziativa rivoluzionaria in Sicilia e si adoperò personalmente molto sia con Cavour che con Garibaldi, per scrollarli da atteggiamenti negativi verso il futuro dell’Italia. Attivissimo negli ultimi preparativi, Bixio prese il comando di una delle due navi, il “Lombardo” che portavano i volontari in Sicilia, e divenne così il “secondo dei Mille”. La sua partecipazione all’impresa si colorò presto, per l’opinione pubblica italiana, di leggenda, con episodi mitici (si ricorda la ormai famosissima frase di Garibaldi: “Bixio, qui si fa l’Italia o si muore!”) che si univano a fatti autentici di coraggio e di bravura militare. Al comando del I battaglione, partecipò all’assalto del colle di Calatafimi, su cui si trovavano le truppe borboniche, in seguito passando con Garibaldi lo stretto di Messina, affrontando il primo diretto scontro con i difensori di Reggio, mentre il Generale compiva l’aggiramento della città.
Del rivoluzionario mondo garibaldino, il Bixio fu uno dei pochi a riuscire ad inserirsi e ad essere accettato nelle alte sfere dell’Italia ufficiale: ricevette, infatti, la croce di Ufficiale dell’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; eletto deputato a Genova nel 1861 iniziava poi la sua vita politica. Sedette nelle fila della Sinistra, proclamandosi però indipendente da qualunque schieramento politico, erigendosi a mediatore nel drammatico scontro fra Cavour e Garibaldi alla Camera nell’aprile del 1861. Nominato in tutte le legislature membro della Commissione Generale del Bilancio, e in particolare assegnato a quelli della Guerra e della Marina, il Bixio nel 1862 venne inviato come Commissario all’Esposizione Internazionale di Londra e nel 1863 entrò a far parte della Commissione creata dal Parlamento per la questione del brigantaggio. L’amarezza di Bixio per gli sviluppi della guerra crebbe con la crisi dle 1867, che se segnò con Mentana il tramonto del garibaldinismo, mise anche inluce le carenze e gli errori dell’Italia ufficiale. Fu sotto la spinta di questi avvenimenti che egli si decise ad abbandonare l’esercito e la politica (dopo esser stato nel set. 1866 al comando della divisione territoriale di Brescia e nel 1867 a quella di Perugia), prendendo la via del mare con la costruzione della nave a vela e a vapore il “Maddaloni”. Il 6 febbraio 1870 fu nominato Senatore, ma era ormai estraneo alla vita politica, tutto preso dalla costruzione della sua nave. Il 6 luglio 1873 partiva dal Messina per Batavia e per Singapore. Nel mare di Sumatra, colpito di febbre gialla, moriva qualche tempo dopo, il 16 dicembre 1873. La sua tomba provvisoria in un isolotto venne profanata dagli indigeni e solo alcuni anni più tardi i suoi resti, rintracciati sulla spiaggia di Atcin, ebbero la sepoltura definitiva a Genova.
Note:
G. Guerzoni, La vita di Nino Bixio, Firenze, 1875Dizionario del Risorgimento Nazionale. Dalle origini a Roma Capitale. Fatti e Persone, Vol. II, Editore Francesco Vallari, Milano, 1933, pp. 304-308
Dizionario Biografico degli Italiani, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, Vol. 10, Roma, 1968, Società Grafica Romana, pp. 727-734
La documentazione è stata prodotta da:
Persone:
- Bixio Nino, autore
Redazione e revisione:
- Pizzo Marco, 2005/04/16, compilazione
- Pizzo Marco, 2006/03/15, aggiornamento