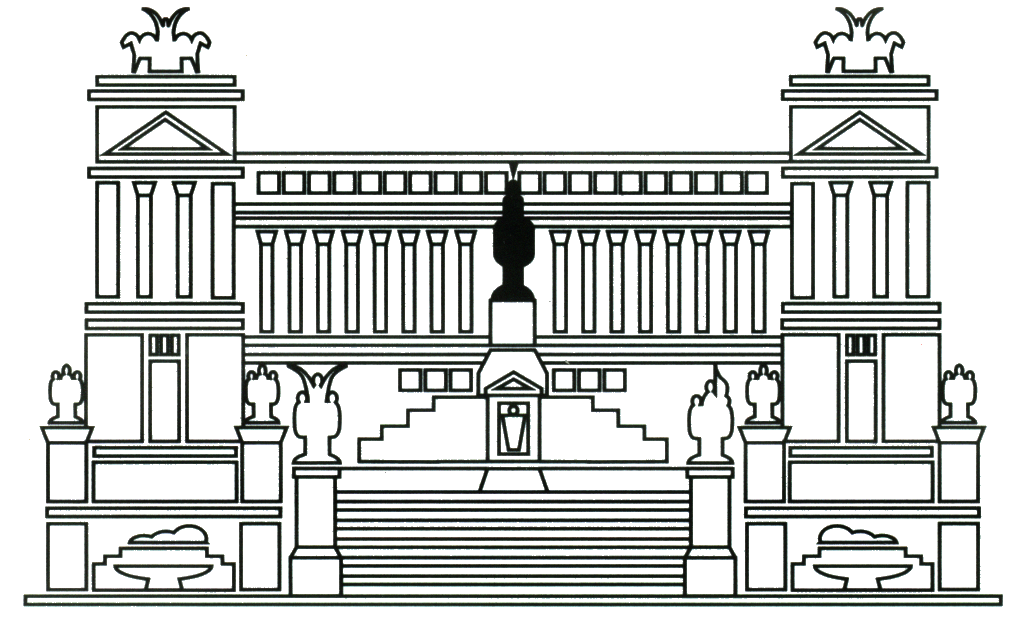Titolo originale:
Fondo CannizzaroTipologia:
fondoData:
(s.d.)Consistenza:
2Descrizione:
Le carte dell´archivio Cannizzaro conservate nelle bb. 393-394 dell´archivio del Museo Centrale del Risorgimento comprendono 369 documenti e 2 stampati, datati tra il 1826 e il 1910.Essi possono essere suddivisi in due gruppi.
Il primo, che comprende i fascicoli 1-24 della b. 393, include corrispondenza privata (comprendente sia lettere ricevute che minute), memorie varie del chimico siciliano e non (anche sulla mafia, sulla situazione dell´ordine pubblico in Sicilia intorno al 1875 e sull´applicazione della Legge Pica per la repressione del brigantaggio ), bozze di discorsi parlamentari, ecc. I fascc. 25-33 della stessa busta e i nn. 1-6 della b. 394 comprendono invece documenti inerenti alla carriera universitaria e politica del Cannizzaro e ai numerosi incarichi da lui ricoperti in seno a vari organismi nazionali o locali (Consiglio Superiore dell´Istruzione Pubblica, Consiglio Straordinario della Provincia di Palermo, Giunta per il miglioramento dell´Industria e del Commercio dello Zolfo in Sicilia, ecc.) e alle numerose onorificenze conferitegli, dallo stato italiano ma non solo. Tale documentazione è costituita dunque da numerosi decreti di nomina o attestati di concessioni di onorificenze e dalle lettere con cui tali provvedimenti vennero trasmessi o comunicati. Troviamo dunque, oltre a decreti di vari dicasteri del Regno d´Italia (in massima parte di quello dell´Istruzione Pubblica), del Regno di Sardegna e del Governo Provvisorio di Sicilia, lettere dei ministeri stessi, delle varie università in cui il Cannizzaro prestò servizio (Pisa, Genova, Palermo, Roma), o, per quello che riguarda le onorificenze, degli Ordini Civile di Savoia, della Corona d´Italia, dei SS. Maurizio e Lazzaro. Purtroppo nella maggior parte dei casi (fanno eccezione ad es. quelli compresi nei fasc. 3 e 4 della b. 394) i decreti sono stati separati dalle relative lettere di trasmissione e raggruppati nel fasc. 33 della b. 393, senza dunque rispettare l´originaria sedimentazione dei documenti .
Storia archivistica:
Nel Museo Centrale del Risorgimento (bb. 393-394) si conserva un fondo denominato “Carte Cannizzaro”, relativo alla figura del più insigne chimico italiano del XIX secolo, protagonista anche delle vicende risorgimentali.Stanislao Cannizzaro nacque a Palermo il 13 luglio 1826 da Mariano e Anna Di Benedetto. Appartenente ad una famiglia di stretta osservanza borbonica (suo padre fu direttore generale della polizia di Sicilia e quindi presidente della Gran Corte dei Conti di Sicilia), nel 1836 fu iscritto al collegio-convitto “Carolino Calasanzio”.
A 15 anni si iscrisse alla facoltà di medicina di Palermo, ove restò fino al 1845 senza conseguire la laurea. Per tre anni frequentò il corso del fisiologo Michele Foderà, e furono proprio le esigenze della fisiologia ad avvicinarlo alla chimica. Seguì quindi il corso di chimica di Filippo Casoria (1842-1843) e partecipò alla VII adunanza degli scienziati italiani (Napoli, 20 settembre-5 ottobre 1845). Nella circostanza il Cannizzaro conobbe il chimico Macedonio Melloni, che lo mise in contatto con Raffaele Piria, che presso la sua cattedra di Pisa stava costituendo la prima scuola italiana di chimica, e di cui il Cannizzaro divenne collaboratore nell’ambito dell’attività di insegnamento e ricerca che caratterizzò gli anni accademici 1845-1846 e 1846-1847.
Tornato in Sicilia per un periodo di vacanza, il Cannizzaro vi si trattenne per partecipare alla preparazione della rivolta contro i Borboni. Prese parte alla rivoluzione come ufficiale di artiglieria, durante l’assedio di Messina. Nel marzo 1848 fu eletto deputato nel Parlamento siciliano, di cui fu segretario.
Inviato a Taormina dopo la caduta di Messina (7 settembre 1848), vi rimase anche dopo l’armistizio del 13 settembre come commissario del governo rivoluzionario. Dopo la rottura dell’armistizio seguì la sorte delle truppe rivoluzionarie, venendo poi inserito nelle liste di proscrizione.
Fu quindi costretto all’esilio, imbarcandosi per Marsiglia (23 aprile 1849) e soggiornando per qualche tempo nella Francia meridionale, per passare poi a Lione e infine a Parigi (ottobre 1849), operando tra l’altro, grazie ai buoni uffici del Piria, nei laboratori di Michel Eugène Chevreul e Jean Louis Guy-Lussac al Jardin des Plantes.
Nel dicembre del 1850 ottenne l’incarico di professore di chimica presso il collegio nazionale di Alessandria , ove soggiornò per quattro anni.
Nell’ottobre del 1855, per interessamento del Piria, il ministro dell’Istruzione Pubblica del Regno di Sardegna, Giovanni Lanza, lo nominò professore di chimica presso l’Università di Genova. Qui, per incarico, tenne anche l’insegnamento di chimica applicata alle costruzioni (1857-1860).
Nel 1858 viene pubblicato il famoso Sunto di un corso di filosofia chimica, dettato dal Cannizzaro alla moglie Enrichetta Whiters, figlia di un pastore inglese, sposata nel 1857.
Dopo l’ingresso di Garibaldi in Palermo, il chimico siciliano fece ritorno nella propria città natale, ove fece parte del Consiglio di Stato straordinario incaricato di studiare ed esporre al governo nazionale i criteri in base ai quali inserire i “bisogni peculiari della Sicilia” nell’ambito della costruzione dell’unità e prosperità del Paese.
Il Cannizzaro insegnò ancora per un anno a Genova, poi nell’ottobre 1861 ottenne finalmente la cattedra di chimica organica e inorganica nell’università di Palermo, che divenne il centro degli studi chimici italiani. Fu anche per alcuni anni rettore dell’ateneo, ricoprendo nel contempo cariche pubbliche nell’ambito dell’amministrazione della sua città. Fu consigliere comunale ed assessore e in occasione dell’epidemia di colera del 1867 venne nominato commissario per la sanità pubblica.
Nel 1870 è tra i fondatori della Gazzetta chimica italiana, pubblicata a Palermo a partire dal 1871 sotto la sua direzione.
Nel novembre 1871 venne chiamato alla cattedra di chimica presso l’università di Roma, ottenendo contemporaneamente (15 novembre 1871) la nomina a senatore.
A partire dal 1872 tenne presso l’ateneo romano i corsi di chimica generale e di chimica inorganica e diresse la Scuola pratica, organizzando inoltre un istituto di chimica che sorse presso il convento di S. Lorenzo in Panisperna, ove restò fino alla costruzione della Città universitaria.
Lasciò l’insegnamento nel 1909, ormai ottantatreenne.
Nel frattempo aveva ottenuto numerosi riconoscimenti, divenendo membro di numerose accademie e associazioni scientifiche nazionali ed estere (nel 1873 fu nominato socio nazionale dell’Accademia dei Lincei). Fu anche vice-presidente del Senato.
Morì a Roma il 10 maggio 1910.
Redazione e revisione:
- Pizzo Marco, 2005/04/16, compilazione
- Pizzo Marco, 2005/09/29, aggiornamento