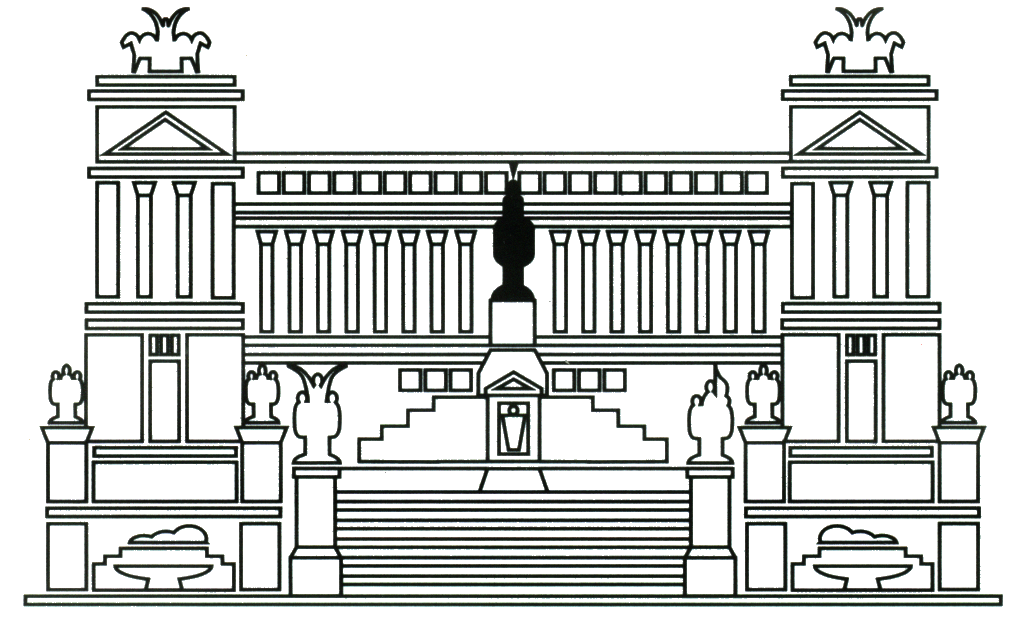Titolo originale:
Fondo Pierantoni AugustoTipologia:
fondoData:
(s.d.)Consistenza:
[non specificata]Descrizione:
Le carte Augusto Pierantoni (B. 767-784), riferite ad una arco cronologico che va dal 1852 ca. al 1911, hanno una consistenza totale di 3125 unità archivistiche, così suddivise: 2676 Documenti, 5 Manoscritti, 432 Stampati, 8 Fotografie,2 Disegni e 3 Incisioni: 3. Il materiale è in buono stato di conservazione.Si tratta di un complesso documentario ricco e articolato, composto di corrispondenza professionale e privata, di bozze e appunti di uno studioso profondamente appassionato non solo al diritto, ma anche alla storia e alla letteratura. Da segnalare, la documentazione relativa alla causa intentata presso il Tribunale Militare di Torino a carico del maggiore Manno e del tenente Francesco Alasia, accusati di prevaricazione e detenuti nella città sabauda. La causa, della quale era stato incaricato Pasquale Stanislao Mancini, fu discussa nel 1867-68 in collaborazione con Pierantoni (MCRR b. 775 fasc. 6, 2; fasc. 5, 8; fasc. 6, 10).
Il fondo conserva per la maggior parte i documenti relativi alla sua vita professionale di Docente Universitario; cospicua è la corrispondenza che egli intrattenne con numerosi studiosi soprattutto stranieri, sia dei paesi europei che di paesi extraeuropei.
Numerose però anche le lettere a carattere più squisitamente privato, scritte o ricevute dai familiari e dai tanti amici; tra i quali appaiono i nomi degli esponenti di spicco delle personalità più eminenti tra gli intellettuali meridionali dell’epoca. Tra gli altri corrispondenti, va segnalata una lettera di Giuseppe Garibaldi da Caprera del 16 ottobre 1876 (MCRR b. 771, f. 24, 9).
Accanto alla corrispondenza, l’Archivio Augusto Pierantoni conserva una notevole quantità di appunti, bozze e minute di pugno del Pierantoni stesso, prevalentemente di carattere storico e letterario oltre che prettamente giuridico, spesso sono stesi su fogli “riutilizzati” e raggruppati da una intitolazione apposta a matita su una camicia costituita da un foglietto ripiegato.
L’archivio inoltre è particolarmente ricco di stampati, sia di pubblicazioni del Pierantoni stesso e delle bozze dei suoi lavori che egli correggeva e rinviava all’editore, sia di numerosi giornali e opuscoli stranieri legati ai suoi interessi professionali e ai suoi soggiorni all’estero.
I documenti nel loro complesso non sembrano aver subito particolari interventi di riordinamento; talvolta sul verso delle lettere o sulle camicie compaiono annotazioni che sembrano risalire ad un epoca di poco successiva alla loro creazione, forse del Pierantoni stesso o di qualche suo allievo o familiare, come è il caso delle note di mano della figlia Dora, che si fece carico di conservare la memoria documentaria dei personaggi della famiglia. La sua preoccupazione di riportare all’ambito originario documenti di varia natura e tipologia affiora nelle note, siglate D. P., che si trovano talvolta sul verso dei documenti o in foglietti conservati accanto al documento stesso: Queste annotazioni tornano con più frequenza nelle carte che ho definito appunti, obbiettivamente difficili da ricollocare in un contesto originario in quanto il più delle volte privi di data; per esempio. sulla traduzione di un articolo riguardante il processo Sbarbaro-Pierantoni (MCRR busta 776 fasc. 6, 1), Dora ha annotato: “Da mettere tra le carte del babbo”
Storia archivistica:
Nato a Chieti il 24 giugno 1840,Augusto Pierantoni iniziò gli studi nella città natale. Frequentava il ginnasio, quando la gestione dell’istituto fu affidato agli Scolopi e il corpo insegnante, fino a quel momento composto da numerosi docenti laici, venne completamente sostituto con religiosi; l’impostazione a suo dire “antilibertaria” che il nuovo orientamento imponeva agli alunni (egli si rifiutò di recitare in pubblico la Bassvilliana) lo portò ad abbandonare gli studi. Tre anni dopo i genitori lo fecero trasferire a Napoli, dove terminò lo studio superiore ed entrò in contatto con gli ambienti liberali della città. La sua passione politica e le difficoltà insorte con il decreto di espulsione dall’ateneo napoletano degli studenti non provenienti dalle province campane di Napoli, Caserta o Salerno dopo l’attentato di Agesilao Milano, gli impedirono d’iscriversi all’Università. Per non essere costretto a lasciare Napoli, infatti, egli dichiarò di non essere studente ma “figlio di famiglia”; rimase pertanto in città e, negli anni 1857-1859, studiò privatamente, entrando in stretto contatto con gli ambienti liberali partenopei seppure tra le ovvie difficoltà. Si dedicò in quel periodo, secondo De Gubernatis, anche all’attività letteraria, componendo un dramma patriottico rappresentato al Teatro de’Fiorentini dal Salvini e da altri.Nel 1860 partì militare e solo dopo la battaglia del Volturno, per interessamento personale dell’allora consigliere della pubblica istruzione Raffaele Piria, s’impiegò a Napoli come applicato nel Ministero della Pubblica Istruzione. Per intervento dello stesso studioso calabrese si trasferì a Torino, nella segreteria particolare di Pasquale Stanislao Mancini e di Carlo Matteucci. Ma dopo poco, con l’annessione di Napoli al Regno d’Italia, Pierantonì rassegnò le dimissioni dall’incarico, per tornare nel capoluogo partenopeo e conseguire la laurea in Giurisprudenza. De Gubernatis riferisce che egli conseguì due lauree, sostenendo 18 esami in un solo mese. in effetti, il 20 maggio 1864 Pierantoni inoltrò un’istanza al Ministero della Pubblica Istruzione per ottenere l’autorizzazione a sostenere gli esami per conseguire due lauree (MCRR, b. 776, fasc. 10, 6)
Dal 1865 iniziò l’attività di scrittore in materia di diritto, dando alle stampe uno studio dall’eloquente titolo Dell’abolizione della pena di morte (Torino, Tipografia del Diritto).
La notorietà della pubblicazione e i meriti scientifici lo portarono nel settembre 1865 alla cattedra di Diritto Internazionale e Costituzionale all’Università di Modena, che lasciò nel 1866 per arruolarsi come artigliere nell’esercito nazionale nella divisione comandata dal Medici.. Fu con Garibaldi in Trentino.
La sua partecipazione attiva ai moti e alle istanze risorgimentali fece sì che egli fosse incaricato dal Comitato dell’emigrazione nizzarda di Firenze di redigere un memorandum (che non fu poi mai presentato) per riportare all’attenzione internazionale la ricongiunzione di Nizza all’Italia.
L’attività forense, iniziata al termine della campagna del’66, lo vide spesso impegnato come difensore in importanti processi politici.
Il 16 gennaio 1868 sposò Grazia Mancini, figlia maggiore di Pasquale Stanislao; la vicinanza con il Mancini, basata su affinità ideologiche e comunione d’interessi e rafforzata dalla parentela, è testimoniata nell’archivio dai numerosi messaggi per lo più a carattere professionale, riguardanti pratiche discusse in collaborazione o con la supervisione del suocero.
A Modena, per i tipi di Vincenzi, nel 1869 diede alle stampe quella che è ritenuta da molti la sua opera più significativa, Storia degli studi di Diritto Internazionale in Italia.
Di nuovo però, nel 1870, non esitò ad impegnarsi nel Comitato Nazionale di Soccorso ai feriti dei due grandi eserciti belligeranti.
Nel 1872 il ministro Cesare Correnti decretò il suo trasferimento all’Università di Napoli; nel 1878 divenne titolare della cattedra di Diritto Internazionale all’Università di Roma.
Eletto deputato per il collegio di Santa Maria Capua Vetere e Caserta I nelle legislature XII, XIII, XIV e XV nelle file della sinistra, è ricordato come uno dei membri più assidui delle sedute parlamentari, impegnato attivamente in numerose commissioni e giunte speciali.
Nel 1873 fu tra i fondatori dell’Istituto di Diritto Internazionale, del quale Pasquale Stanislao Mancini fu nominato primo Presidente. Dal 1878 ricevette la nomina di Consigliere del Contenzioso Diplomatico. Fu spesso incaricato di missioni all’estero: nel 1885 fu Delegato italiano alla Conferenza Internazionale di Parigi nella Commissione internazionale per la legiferazione sulla circolazione nel canale di Suez. Nella capitale francese fu tra i membri del Congresso internazionale Penitenziario nel 1895. Nel 1903 fu tra i membri fondatori dell’ Institut international de la Paix.
La sua fama di giurista, riconosciuta unanimemente, lo portò a collaborare con numerose riviste scientifiche sia italiane che straniere.
Numerose sono le onorificenze di cui fu insignito, molte delle quali conservate nel suo archivio (Commenda dell\'ordine del Salvatore di Grecia, Grand\'ufficiale dell\'Ordine della Corona d’Italia, Commendatore dell\'ordine dei santi Maurizio e Lazzaro).
Per meriti accademici, ricevette inoltre la laurea honoris causa dalle università di Oxford (1895) e di Edimburgo (1905).
Nominato Senatore con Regio Decreto del 25 novembre 1883, morì a Roma il 12 marzo 1911.
Note:
Su Augusto Pierantoni si vedano: Angelo De Gubernatis, Piccolo dizionario dei contemporanei italiani, v. II,, pp. 693-696; Telesforo Sarti o, Il parlamento subalpino e nazionale: Profili e cenni biografici di tutti i deputati e senatori eletti e creati dal 1848 al 1890 (legislature XVI), Terni, 1890., pp. 763-764; Alberto Malatesta, Ministri, deputati, senatori dal 1848 al 1922, vol. II, p. 320Per una bibliografia completa delle opere di A. Pierantoni si veda Raffaele Aurini, Dizionario bibliografico della gente d’Abruzzo, Teramo 1952, v. 2, pp. 305-324.
Il deposito delle carte della famiglia Mancini-Pierantoni avvenne in momenti diversi: si vedano gli articoli di E. Morelli, Gli acquisti recenti, in: Rassegna Storica del Risorgimento, XXVII, 1940, IX-X, pp. 514-516; Le carte Mancini, in R.S:D:R., XXVIII, 1941, I, pp. 100-103; Le carte Pierantoni, in R.S.D.R., XLI, 1954, I, pp. 105-110; Le carte di P. S. Mancini, ministro di grazia e giustizia 1876-1878, in R.S.D.R., LXX, 1983, III, pp. 321-326; Le ultime carte di Pasquale Stanislao Mancini, in R.S.D.R., LXX, 1983, IV, pp. 464-469 ora ripubblicati ne I fondi archivistici del Museo Centrale del Risorgimento, Roma 1993.
Redazione e revisione:
- Pizzo Marco, 2005/04/16, compilazione
- Pizzo Marco, 2006/03/07, aggiornamento