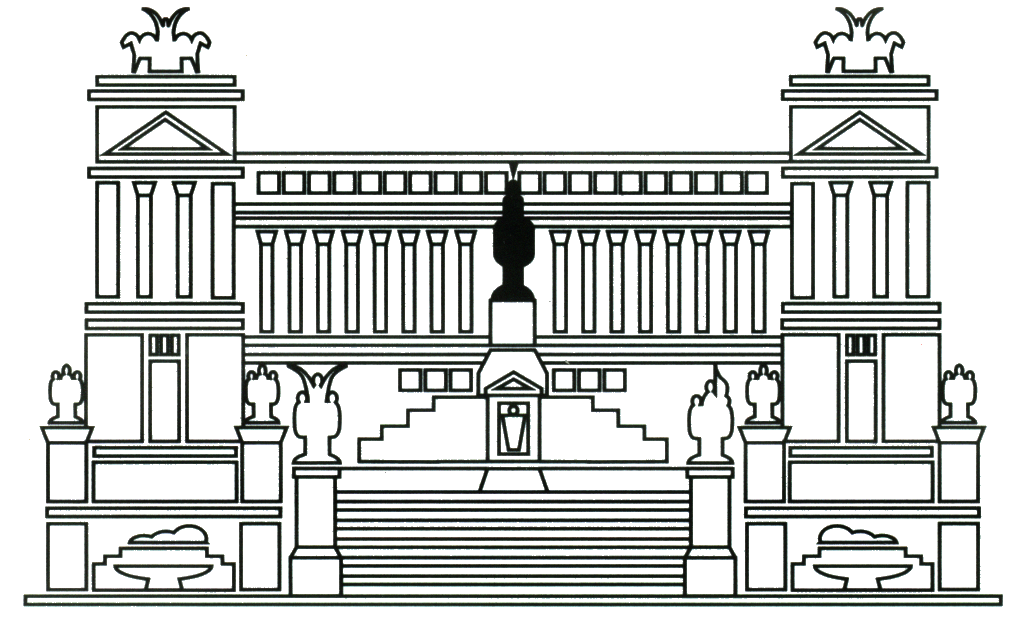Titolo originale:
Fondo CapelloTipologia:
fondoData:
(s.d.)Consistenza:
[non specificata]Descrizione:
Il fondo archivistico del Gen. Luigi proviene dalla donazione che la figlia del generale ha voluto donare al Museo Centrale del Risorgimento di Roma, quella documentazione che la famiglia riuscì a salvare dalla perquisizione del 1925, in seguito all’attentato a Mussolini, che vide come principale personaggio l’On. Zaniboni, ma che causò al Capello una lunga detenzione in carcere di cui sono testimonianza le lettere alla moglie dal 1926 al 1928.Queste carte sono state conservate e raccolte nelle buste 895 – 900: la consistenza è piuttosto notevole dal momento che la busta 895 si compone di 100 fascicoli; la busta 896 di 1 fascicolo; la busta 897 di 2 fascicoli; la busta 898 di 10 fascicoli; la busta 899 di 9 fascicoli; la busta 900 di 14 fascicoli.
La documentazione raccolta presenta una diversificata tipologia archivistica essendo costituita da lettere, minute, cartoline postali, telegrammi, stampati (ritagli di articoli di giornale), relazioni, memorie, appunti, manoscritti, carte topografiche, ordini del giorno, circolari, una fotografia e un disegno. L’arco cronologico va dal 1912 al 1959
E’ opportuno segnalare alcune carte interessanti per comprendere la struttura e la composizione di questo fondo, in seguito all’analisi svolta nel corso della schedatura presso il Museo Centrale del Risorgimento:
- N.21 lettere scritte dal Luigi Capello dal carcere di Roma alla moglie Lidia Bongiovanni dal 16 gen. al 10 set. 1926 (B.895 – F.26).
- Lettera in cui il Sovrano Gran Commendatore della Massoneria Enrico Ballerini comunica a Luigi Capello (Roma, 23.8.1912) la sua promozione al 30° grado della Rituale Gerarchia del Rito Scozzese Antico ed Accettato (B.895 – F.9).
- N.21 lettere scritte dal Luigi Capello dal carcere di Roma e dal penitenziario di S. Giminiano a Siena, dirette alla moglie Lidia Bongiovanni dal 24 set. 1926 al 17 ott. 1927 (B.895 – F.27).
- N.15 lettere scritte dal Luigi Capello dal penitenziario di S. Giminiano a Siena e poi dal carcere di Soriano nel Cimino dirette alla moglie Lidia Bongiovanni dal 6 nov. 1927 al 20 nov. 1928 (B.895 – F.28).
- Busta contenente un “fiore”, probabilmente una foglia d’alloro con fiore, inviato da Luigi Illica a Luigi Capello (S. Antonio di Castellarquato, 24.1.1918). Nella lettera a cui è allegato, Luigi Illica dice: “Il mio giardino, benchè di gennaio, dà fresco un fiore, unico suo fiore oggi, fiore sacro, fiore votivo, fiore italiano. V.a E.a permette che qui lo accluda? Per Luigi Capello! Per la Riscossa! Per l’Italia” (B.895 – F.57).
- Lettera di “Zia Rosina” inviata a “Niny” nella quale si allude a una richiesta circa notizie su episodi di vita extraconiugale di suo padre (non si specifica il nome). La lettera è datata Cuneo, 4.12.1958 (B.895 – F.62).
- Lettera nella quale Tommaso Filippo Marinetti comunica a Luigi Capello (s.d.) la sua simpatia per il “Grande Generale Italiano Capello, al grido di Viva l’Italia! Morte agli Austriaci” (B.895 – F.64).
- Lettera nella quale Tommaso Filippo Marinetti esprime a Luigi Capello (Milano, 11.2.1919) la sua grande ammirazione per sostenere la reputazione dopo la sconfitta di CAporetto (B.895 – F.64). La lettera si trova esposta dal giugno 2002 nella Sezione Civica del Museo Centrale del Risorgimento di Roma.
- Lettera anonima inviata a Luigi Cadorna (Cormons, 4.8.1917) incui si asseriva che l’esercito italiano era in mano alla Massoneria, la quale “…fin dai primi giorni della guerra ha fatto in modo di occupare tutti i comandi della zona di guerra e territoirale”; si aggiunge inoltre che L. Cadorna fosse circondato dagli affiliati alla Massoneria i quali lo spiavano e cercavano di portarlo alla rovina; che il nemico era perfettamente al corrente della situazione italiana grazie alle spie dimoranti in Gorizia; che i soldati di 1^ linea fraternizzavano con il nemico e che le truppe mostravano un fittizio spirito offensivo (B.895 – F.78).
- Lettera di Ardengo Soffici a Luigi Capello (15.11.1918) con una scritta a stampa nel margine destro superiore: “Soldato! I nostri nemici sono atroci e avidi di conquiste. Per aver la pace bisogna batterli. La tua vittoria al Piave ed al Grappa è stata un gran passo verso la pace”. (B.895 – F.93).
- Lettera di Ardengo Soffici a Luigi Capello (Udine, 15.12.1918) con una scritta a stampa nel margine destro superiore: “Il Soldato che on fa il suo dovere danneggia i propri compagni e allunga la Guerra. Le Madri, le Spose, le Sorelle, non devono attristare i soldati, ma incoraggiarli a fare il loro dovere. E’ dovere di ogni cittadino italiano aiutare moralmente e materialmente i combattenti e le loro famiglie”. (B.895 – F.93).
- Lettera di Ardengo Soffici a Luigi Capello (9.2.1919) con una scritta a stampa nel margine destro superiore: “Durante quattro anni di guerra Soldato hai imparato a conoscere la Grandezza la Forza la Bellezza d’Italia. Col tuo eroismo l’hai santificata. Tornato a casa fai che i tuoi figli sappiano e facciano quello che sai ed hai fatto tu”. (B.895 – F.93).
- Memoria inviata da Giovanni Semeria (cappellano militare presso il Comando Supremo) a Luigi Capello (Roma, giugno 1920) dal titolo “Memorie di Guerra offerte per gli orfani a tutti i buoni Italiani”. Sul frontespizio vi è la dedica manoscritta a Luigi Capello: “A S.E. il Generale Capello, sperando che questo libro dove si parla con affettuosa reverente sincerità non gli dispiaccia ed egli voglia essere buon amico dei suoi orfanelli. P.G. Semeria. Natale 1924” (B.895 – F.100).
- Volume dattiloscritto di Luigi Capello (Roma, 5.6.1918) dal titolo “La 2^ Armata e l’offensiva austro-tedesca dell’ottobre 1917”. Si tratta della prima appendice documentaria al testo che il Gen. Capello non potè mai pubblicare. E’ ordinata logicamente secondo questi paragrafi: 1) “Istruzione e Disciplina” – 2) “Indirizzo tattico dell’artiglieria” – 3) “Le mitragliatrici nella difesa” – 4) “Comunicazioni e collegamenti” – 5) “Appoggio reciproco fra unità laterali” – 6) “Affluenza tempestiva al ciglio di fuoco” – 7) “Il principio generale dell’economia delle forze e dello scaglionamento in profondità” – 8) “Manovra, contrattacco, attanagliamento, incapsulamento” – 9) “La preparazione tecnica e morale delle truppe” – 10) “Le varie fasi del concetto difensivo” – 11) “Misure prudenziali, provvedimenti attuati” – 12) “Lo stato di fatto, situazione” – 13) “Rinforzi e sottrazioni di forza allo scatenarsi dell’offensiva” – 14) “L’azione sulla fronte del IV Corpo” – 15) “L’azione sulla fronte del XXVII Corpo” – 16) “L’azione del VII Corpo” – 17) “La difesa sulle linee arretrate” – 18) “Gli ordini del ripiegamento e della resistenza” – 19) “Cause, errori, accuse, giustificazioni” – 20) “Referti sanitari” – 21) “Corrispondenza fra il Comando Supremo e il gen. Capello dopo il 28 ottobre”. Le copie di questi documenti sono quasi tutte autenticate ed esistono anche alcuni originali, con i riassunti delle conferenze tenute ai soldati dal Gen. Capello dall’8 apr. 1917 al 18 gen. 1918 (B.896 – F.1)
- Carta topografica (24.10.1917) riguardante lo “Schieramento dell’Artiglieria al 24 ottobre 1917” sul fronte tra Gorizia e Caporetto. Vi è segnalata la dislocazione del IV – XXVII – II – VI e VIII Corpo d’Armata. Questa carta topografica è annessa la documento N.13 pag.24 dell’Appendice documentaria dattiloscritta del Gen. Luigi Capello “La 2^ Armata e l’offensiva austro-tedesca dell’ottobre 1917”. (B.896 – F.1).
- Schizzo topografico (24.10.1917) riguardante gli “Obiettivi per tiro e liquidi speciali” sul fronte tra Gorizia e Caporetto. Questa schizzo topografico è annesso la documento N.13 pag.24 dell’Appendice documentaria dattiloscritta del Gen. Luigi Capello “La 2^ Armata e l’offensiva austro-tedesca dell’ottobre 1917”. (B.896 – F.1).
- Carta topografica (24.10.1917) riguardante la “Situazione sulla fronte della 2^ Armata alle ore 6 del 24 ottobre” sul fronte tra Gorizia e Caporetto. Vi è segnalata la dislocazione della “Brigata Napoli”, della “14^ Armata Below”, del “Gruppo Krauss (I° Corpo A.U.)”, del “Gruppo Stein (III° Corpo Bavarese)”, del “Gruppo Berrer (III° Corpo P.R.)” del “Gruppo Scotti (XV° Corpo A.U.)”. Questa carta topografica è annessa al documeto N.53 pag.132 dell’Appendice documentaria dattiloscritta del Gen. Luigi Capello “La 2^ Armata e l’offensiva austro-tedesca dell’ottobre 1917”. (B.896 – F.1).
- Carta topografica (24.10.1917) riguardante la “Sistemazione difensiva sulla fronte della 19^ Divisione” sul fronte tra Gorizia e Caporetto. Questa carta topografica è annessa al documeto N.99 pag.209 dell’Appendice documentaria dattiloscritta del Gen. Luigi Capello “La 2^ Armata e l’offensiva austro-tedesca dell’ottobre 1917”. (B.896 – F.1).
- Carta topografica (24.10.1917) riguardante “Il Tagliamento, il Fella e le prealpi Carniche”. Questa carta topografica è annessa al documeto N.137 pag.255 dell’Appendice documentaria dattiloscritta del Gen. Luigi Capello “La 2^ Armata e l’offensiva austro-tedesca dell’ottobre 1917”. (B.896 – F.1).
- Carta topografica (23.10.1917) riguardante il “Comando della 2^ Armata. Dislocazione alle ore 12 del 23 ottobre 1917” sul fronte tra Gorizia e Caporetto. Questa carta topografica è segnalata come “Documento N.249 bis” dell’Appendice documentaria dattiloscritta del Gen. Luigi Capello “La 2^ Armata e l’offensiva austro-tedesca dell’ottobre 1917”. (B.896 – F.1).
- Bozza dattiloscritta (5.6.1918) dell’opera mai pubblicata di Luigi Capello dal titolo “L a 2^ Armata e l’offensiva austro-tedesca dell’ottobre 1917”. Questa bozza è divisa in due parti ed 8 capitoli, con una “Conclusione” e una “Nota Aggiuntiva”: 1) pag.1-20 “Premessa” – 2) pag.21-42 “Parte I, Capitolo 1° “Cooperazione dei Comandi Dipendenti” – 3) pag.43-80 “Parte I, Capitolo 2° Spirito delle truppe e preparazione tecnica e morale” – 4) pag.81-128 “Parte I, Capitolo 3° Criteri tattici presso la 2^ Armata” – 5) pag.129-180 “Parte I, Capitolo 4° L’indirizzo tattico dell’Artiglieria” – 6) pag.181-216 “Parte I, Capitolo 5° Varie fasi del concetto difensivo” – 7) pag.217-304 “Parte I, Capitolo 6° Predisposizioni difensive” – 8) pag.305-380 “Parte I, Capitolo 7°Gli avvenimenti” – 9) pag.381-400 “Parte I – Capitolo 8° La necessità del ripiegamento” - 10) pag.401-438 “Conclusione” – 11) pag.439-473 “Nota aggiuntiva” (B.897 – F.1).
- Volume dattiloscritto di Luigi Capello (Roma, 5.6.1918) dal titolo “L a 2^ Armata e l’offensiva austro-tedesca dell’ottobre 1917”. Si tratta della seconda appendice documentaria “Raccolta supplementare di documenti” al testo che il Gen. Capello non potè mai pubblicare. E’ ordinata logicamente secondo questi paragrafi: 1) “La cooperazione dei comandi dipendenti” - 2) “Aggiunta al Capitolo 1°: Istruzione e disciplina” – 3) “Aggiunta al Capitolo 2°: L’indirizzo tattico dell’artiglieria” – 4) “Aggiunta al Capitolo 3°: Le mitragliatrici nella difesa” – 5) “Aggiunta al Capitolo 4°: Conoscenza e occupazione delle linee di difesa” – 6) “Aggiunta al Capitolo 5°: Comunicazioni e collegamenti” – 7) “Aggiunta al Capitolo 6°: Appoggio reciproco fra unità laterali” – 8) “Aggiunta al Capitolo 8°: Principio generale dell’economia delle forze e dello scaglionamento in profondità” – 9) “Aggiunta al Capitolo 9°: Manovra – Contrattacco – Attanagliamento – Incapsulamento” – 10) “Aggiunta al Capitolo 10°: La preparazione tecnica e morale delle truppe” – 11) “Aggiunta al Capitolo 11°: Le varie fasi del concetto difensivo” – 12) “Aggiunta al Capitolo 12°: Misure prudenziali – Provvedimeti attuati” – 13) “Aggiunta al Capitolo 13°: Lo stato di fatto – Situazioni” – 14) “Aggiunta al Capitolo 19°: Gli ordini di ripiegamento e della resistenza“ – 15) “Aggiunta al Capitolo 20°: Cause – Errori – Accuse – Giustificazioni” – 16) “Aggiunta al Capitolo 21°: Referti Sanitari”. (B.897 – F.2).
- Bozza dattiloscritta (Roma, 5.6.1918) “Appendice alla raccolta di documenti” dell’opera mai pubblicata di Luigi Capello dal titolo “La 2^ Armata e l’offensiva austro-tedesca dell’ottobre 1917” con allegata una carta topografica riguardante lo “Schieramento dell’Artiglieria al 24 ottobre 1917” sul fronte tra Gorizia e Caporetto”.(B.898 – F.1).
- Fascicolo intitolato “Originali dei documenti annessi al lavoro di Luigi Capello” contenente lettere, telegrammi, minute, appunti, relazioni, memorie del periodo 1916 – 1917 (B.898 – F.2).
Si segnala:
a) - relazione medica del 16 nov. 1917 redatta dal Colonnello medico Direttore di Sanità, Dott. Morino, relativa allo stato di salute del Gen. Capello ed in particolare veniva descritta la sua malattia cominciata ai primi di ottobre 1917 con una lieve infezione intestinale che in seguito si complicò e si concluse con il ricovero all’Ospedale Militare di Verona.
b) - lettera del Gen. Luca Montuori a Luigi Capello (6.12.1917) con spiegazioni relative alla disfatta di Caporetto.
c) - minuta di Luigi Capello al Gen. Della Noce (6.12.1917) relativa al funzionamento del Comando del IV Corpo d’Armata.
d) - pratica redatta dal Gen. Capello (8.12.1917) “N.198 di prot. Op.: Breve riassunto degli avvenimenti di Ottobre (Richiesto da S.E. il Ministro della Guerra con telegramma 134748 del 7 dicembre 1917)”.
- Fascicolo intitolato “Originali dei documenti annessi al lavoro di Luigi Capello” contenente promemoria, rapporti, interrogatori, pratiche, relazioni del periodo1917 (B.898 – F.3).
- Volume manoscritto delle conferenze tenute in guerra dal Gen. Luigi Capello del periodo 8 apr. 1917 – 20 gen. 1918 (B.898 – F.9).
- Bozza dattiloscritta dell’opera del Gen. Capello “L’essenza del mio concetto difenzivo. Il mio egoismo. Il mio interessamento per le truppe” del gennaio 1919 (B.899 – F.1).
- Bozza dattiloscritta dell’opera del Gen. Capello “Alcune note sulla nostra guerra” suddivisa in due capitoli: capitolo 1 “Dall’inizio a Caporetto”; capitolo 2 “Poche note: da Caporetto alla Vittoria” del dicembre 1918 (B.899 – F.2).
- Fascicolo intitolato “Carte varie di Luigi Capello riguardanti la prima guerra mondiale” contenente 6 documenti tra cui alcuni brani della lettera di Luigi Capello al Ministro Leonida Bissolati dopo la presa di Gorizia (ago. 1916); un promemoria di Luigi Capello del 1 set. 1916; una lettera di S. Piacentini (Tenente Generale Comandante la 2^ Armata) diretta a Luigi Capello del 7 set. 1916; una lettera di Capello ai vari Comandi del 24 feb. 1917; un rapporto di Ario Ajraghi dell’inizio del 1900; una lettera (s.d.) di Laura Capello, figlia del generale, alla Signora Morelli relativa al fatto che la “presa di Gorizia” segnò il principio dei grandi guai sofferti dal padre.
- N.2 Relazioni (8 - 9 gen. 1916) del dott. Gerundo (Direttore di Sanità del VI Corpo d’Armata) dal titolo “Relazioni sullo stato sanitario e morale delle truppe” (B.899 – F.4).
- Relazione di Luigi Capello sulle “condizioni delle truppe” del 1916 (B.899 – F.4).
- “Relazione sulla ritirata della 2^ Armata dall’Isonzo al Piave del Gen. Montuori con documenti e carte topografiche annessi (Copia)” dell’ott. – nov. 1917 (B.899 – F.5).
- Fascicolo intitolato “Carte riguardanti il morale delle truppe nella prima guerra mondiale. Azione Sabotino” contenente N.14 documenti di lettere e relazioni del periodo 3 nov. 1915 – 8 set. 1916 (B.899 – F.6).
- Numerosi ritagli di giornale riguardanti “Luigi Capello e la guerra” complessivamente del periodo 22 lug. 1917 – 5 feb. 1859 (B.899 – FF.8 – 9).
- Volume a stampa contenente la relazione “La Battaglia del Montello” e 11 allegati di cartografia militare del luglio 1918 (B.900).
- Lettere, minute, rapporti e memorie riguardanti la Campagna di Libia (6 mar. 1912 – 11 giu. 1913) ed in particolare si segnala una memoria manoscritta di Luigi Capello dal carcere di Roma Regina Coeli su questo argomento (B.900).
- Copia della dichiarazione dattiloscritta (Roma, 10.3.1923)relativa alla vertenza fra il capitano Cesare Forni (Ispettore Gen. della Prima Zona della Milizia Nazionale) e l’Avv. Francesco Giunta (Ispettore Gen. della Sesta Zona della Milizia Nazionale) circa offese espresse dall’On. Giunta verso il Cap. Forni durante l’ultima riunione del Gran Consiglio del Fascismo (B.900).
- Memoria intitolata “Scritto su Caporetto dall’Aspirante Aureliano Fusarini scritto nel Cellelager” redatta nel 1918 (B.900).
- Numerosi ritagli di giornale sul processo Zaniboni e sulla posizione di Luigi Capello del periodo 6 nov. 1925 – 27 apr. 1927 (B.900).
- Fascicolo intitolato “Carte riguardanti la riabilitazione di Luigi Capello” contenente alcune lettere del periodo 24 apr. 1945 – 23 nov. 1951 (B.900).
Si segnala:
a) – lettera di risposta del Ministro della Guerra A. Casati diretta a Lidia Bongiovanni Capello (moglie del Gen. Luigi Capello) datata Roma, 24.4.1945, circa la sua richiesta di concessione della riabilitazione militare e del grado di “Maresciallo d’Italia” per il marito. Il Ministro della Guerra comunicava di prendere in considerazione la possibilità della revisione della sentenza (22 apr. 1927) del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, con la quale venne condannato il Gen. Capello e venne privato del grado.
b) - lettera del Ministro della Guerra a Lidia Bongiovanni Capello (moglie del Gen. Luigi Capello) datata Roma, 13.10.1947 nella quale comunicava che erano state concesse la riabilitazione e la reintegrazione nel grado di Generale d’Armata nella riserva al Gen. Capello, con decreto legislativo del Capo di Stato del 5 ago. 1947 N.1015, pubblicato al N.230 del 7 ott. 1947 della Gazzetta Ufficiale.
- Fascicolo intitolato “Carte riguardanti la Commissione d’Inchiesta su Luigi Capello” contenente N.3 interrogatori e una relazione del periodo 16 mar. 1918 (B.900). Si segnala in particolare la copia della trascrizione dell’interrogatorio del Gen. Luigi Capello presso la Commissione Militare d’Inchiesta “Seduta antimeridiana del giorno 16 marzo 1918 – ore 10”.
- - Fascicolo intitolato “Carte riguardanti la detenzione Luigi Capello al Tribunale Speciale” con documentezione del periodo 11 apr. 1927 – 14 mar. 1929 (B.900).
Si segnala:
a) – Autorizzazione del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato (Roma, 11.4.1927) per Lidia Bongiovanni Capello e le figlie Laura, Lina e Giulia allo scopo di poter transitare nel Palazzo di Giustizia fino agli Uffici del Tribunale Speciale per tutta la durata del processo del Gen. Luigi Capello.
b) – Dichiarazione del maresciallo dei Carabinieri della stazione di Monteverde, Giuseppe Lanzillotta, di aver ricevuto da Lidia Bongiovanni Capello il brevetto N.11394 di concessione della medaglia di bronzo al valor militare e relativa medaglia di bronzo con nastro ed astuccio, appartenuti al Gen. Capello, al fine di essere restituiti al Comando del Distretto Militare di Novara (Roma, 14.3.1929).
c) – Appunti manoscritti di Luigi Capello durante la detenzione (s.d.)
Storia archivistica:
Intra (Novara) 14 apr. 1859 – Roma 25 giu. 1941Avviato alla carriera militare dal padre Enrico Volpi, funzionario dei telegrafi, Luigi Capello iniziò come allievo dell’Accademia Militare nel 1875, divenendo Sottotenente di fanteria nel 1878 e in seguito frequentò la Scuola di Guerra conseguendo il brevetto di Ufficiale di Stato Maggiore. Oltre agli interessi militari rivelò ben presto spiccate doti letterarie, tanto da collaborare nel 1893 al Corriere di Napoli insieme con F. S. Nitti e G. D’Annunzio. Nei suoi articoli di critica militare sosteneva la necessità dell’offensiva e dello spirito di iniziativa a tutti i livelli, denigrando lo spirito di casta dell’esercito e il criterio burocratico dell’avanzamento per anzianità. Nel 1898 ebbe la promozione a Colonnello e il comando del 50° Reggimento di Fanteria, entrando in questo periodo all’interno della massoneria, dove raggiunse posizioni di responsabilità e strinse relazioni con personalità politiche. Nel 1910 divenne Maggiore Generale e Comandante della Brigata Abruzzi partecipando alla Campagna di Libia.
Allo scoppio del conflitto mondiale Luigi Capello era al comando della 25^ Divisione a Cagliari, interessandosi ampiamente alla preparazione morale dei soldati. Prese parte così alle prime battaglie sul Carso, in cui si distinse in modo particolare la sua Brigata Sassari. Il 28 set. 1915, promosso Tenente Generale, fu destinato al comando del VI Corpo d’Armata che fronteggiava l’esercito austro-ungarico a Gorizia. Il VI Corpo d’Armata sferrò svariati e sanguinosi attacchi nel corso della terza e della quarta battaglia dell’Isonzo (ott. – nov. 1915), senza riuscire ad intaccare la linea di resistenza nemica, ma tali insuccessi non intaccarono il prestigio di Luigi Capello. Il 6 ago. 1916 fu sferrata l’offensiva, questa volta con risultati migliori e il terribile caposaldo austro-ungarico fu conquistato con un attacco quasi senza perdite. Le truppe del VI Corpo d’Armata giunsero l’8 agosto sull’Isonzo e conquistarono il 9 agosto Gorizia, dove però si dovettero fermare difronte le nuove posizioni nemiche.
La popolarità di Capello ebbe una grandiosa crescita tanto da metterlo in contrasto con il Gen. Cadorna. Luigi Capello veniva visto come il degno successore di Cadorna: era favorito dalle sue indubbie qualità militari, dalla sua familiarità con gli ambienti politici interventisti, dai legami stretti con molti giornalisti e dall’ascendente su giovani ufficiali di complemento come Alessandro Casati e Ardengo Soffici. Il Gen. Cadorna quindi il 12 set. 1916 rimosse Luigi Capello dal comando del VI Corpo d’Armata trasferendolo a quello assai di minor rilievo del XIII Corpo d’Armata sugli Altopiani. Il 13 dic. 1916 Capello passò a comandare il V Corpo della I^ Armata e il 28 dicembre gli fu conferita la nomina a Grande Ufficiale dell’Ordine Militare di Savoia per la parte avuta nella vittoria di Gorizia. Il Cadorna nel 1917, riconoscendo le virtù militari del Gen. Capello, lo richiamò sul fronte dell’Isonzo. Nella Battaglia di Bainsizza (18 ago. – 15 set. 1917) la conquista di questo altopiano costituì un grande successo tattico, specialmente in confronto al fallimento della contemporanea offensiva sul Carso. In vista di vari successi Luigi Capello il 6 ott. 1917 fu fatto Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine Militare di Savoia. Tra il 9 e il 23 ottobre 1917 Capello fu costretto a letto dalla nefrite, tanto da cedere il comando dell’armata al Gen. Montuori, pur continuando ad esercitarlo di fatto. Il 23 ott. 1917 Luigi Capello riprese formalmente il comando della 2^ Armata, nell’imminenza dell’offensiva austro-tedesca, benchè tutt’altro che ristabilito. Il 24 ottobre si scatenò l’attacco nemico che raggiunse rapidamente Caporetto, prendendo a rovescio l’estrema sinistra della 2^ Armata. La profondità e la velocità della penetrazione dei reparti tedeschi sconvolsero tutte le predisposizioni italiane impedendo un’efficace azione di comando. Il 25 ottobre Luigi Capello propose al Gen. Cadorna di ordinare la ritirata generale sul Tagliamento per permettere all’esercito di riprendere fiato e fiducia. Capello diramò anche le direttive per la ritirata della 2^ Armata e poi fu costretto a lasciare il comando per il precipitare delle sue condizioni di salute: fu costretto ad assistere agli sviluppi del disastro dall’Ospedale mentre il comando della 2^ Armata passava al Gen. Montuori.
Il 26 nov. 1917 Luigi Capello, ristabilito, prendeva il comando della nuova 5^ Armata, godendo della fiducia del nuovo Comando Supremo del Gen. Diaz. Tuttavia l’8 feb. 1917 Capello fu privato del comando e posto a disposizione della Commissione d’Inchiesta nominata dal governo Orlando per far luce sulle cause della rotta di Caporetto. Contro la tendenza del governo e della Commissione di addebitare le maggiori responsabilità a Cadorna e al Capello, questi si battè energicamente stendendo tra il marzo e il maggio del 1918 una documentata memoria difensiva “La 2^ Armata e gli avvenimenti dell’Ottobre 1917”. Lottò purtroppo contro il crescente isolamento che raggiunse il culmine nel 1919 con la pubblicazione della relazione della Commissione d’Inchiesta: la Commissione rigettava la colpa di Caporetto su alcuni generali (in primo luogo su Cadorna e Capello) accusandoli di aver logorato le truppe con sforzi eccessivi e di aver male impostato la battaglia difensiva. Il 3 settembre 1919 fu annunciato il collocamento a riposo di Cadorna e di Capello, indicati come i veri responsabili del disastro.
Luigi Capello contro questa condanna morale condusse una lunga battaglia: inivò al governo un memoriale difensivo chiedendo un giudizio in contraddittorio; mandò al Senato una petizione per ottenere una nuova inchiesta; nel 1920 si rivolse all’opinione pubblica con due libri “Per la verità” e “Note di guerra”; prendeva parte al dibattito per la riorganizzazione dell’esercito scrivendo sul Giornale del popolo alcuni articoli molto polemici contro le gerarchie militari, articoli in seguito riuniti in volume col titolo “L’ordinamento dell’esercito” con prefazione di Ardengo Soffici.
Nel 1920 Luigi Capello aderì al fascismo anche se alcuni fogli fascisti non gli avevano risparmiato attacchi per la rotta di Caporetto. Non ebbe però responsabilità e cariche nel partito. La sua adesione al fascismo culminò con la partecipazione in camicia nera alla parata del 31 ottobre 1922 per festeggiare il successo della marcia su Roma. Nel 1923 il Gran Consiglio del partito fascista decise la incompatibilità tra l’iscrizione al partito e quella alla massoneria, così Luigi Capello decise di restituire la tessera fascista. Intanto si era formata una nuova Commissione d’Inchiesta sulla disfatta di Caporetto, la quale alleggerì di molto le accuse mosse a Capello, salvando la sua lealtà di comandante, il suo interesse per i soldati e sostenendo di non poter attribuire la responsabilità di un tale disastro solamente a pochi uomini. Tuttavia queste conclusioni non furono rese pubbliche perché il governo fascista condizionò la riabilitazione di Luigi Capello, secondo le affermazione della figlia del Generale Laura Borlenghi Capello, ad una rottura con la massoneria e da una pubblica dichiarazione di adesione al fascismo. Il Gen. Capello rifiutò nettamente tali condizioni, preferendo l’isolamento al rinnegamento dei suoi principi: così le conclusioni della seconda Commissione d’Inchiesta furono pubblicate solo nel 1946 dalla figlia Laura.
Nel 1925 Capello si adoperò insieme con l’esponente socialdemocratico Tito Zaniboni alla creazione di una rete insurrezionale antifascista, denominata “Pace e libertà” e inizialmente sostenuta dalla massoneria. Mentre Capello si convinse ben presto della mancanza di basi di questa impresa mettendosi in disparte, Zaniboni organizzava un attentato a Mussolini: fu infatti arrestato il 4 nov. 1925 prima di aver attuato i suoi propositi. Il 5 novembre fu arrestato anche Luigi Capello con accuse di complicità nella preparazione dell’attentato, senza che fosse provato niente di concreto a suo carico. Venne celebrato il processo nell’aprile del 1927 dinanzi al Tribunale Speciale, processo che si concluse con la condanna di Capello a trent’anni di reclusione e la radiazione dai ruoli dell’esercito. Dopo una serie di trasferimenti in varie carceri, in seguito al peggioramento della sua salute, alla fine del 1928 Capello fu destinato a una clinica di Formia. Nel 1935 fu trasferito a Roma e nel 1936 fu rimesso in libertà con un provvedimento di fatto, nonostante la condanna continuasse ad essere in vigore. Gli ultimi anni di vita di Luigi Capello furono purtroppo amareggiati dall’impossibilità di riavere la divisa e i gradi militari.
Note:
Si rimanda al saggio critico di Emilia Morelli, I fondi archivistici del Museo Centrale del Risorgimento, Quaderni di Clio – 9, La Fenice Edizioni – Roma, 1993, pp.191-199.L. Borlenghi Capello, Numero 3264: generale Capello, Milano 1946
Dizionario Biografico degli Italiani, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, Vol. 18, Roma, 1975, Società Grafica Romana, pp. 497-502
D. Ascolano, Luigi Capello, Longo, 1999
Redazione e revisione:
- Pizzo Marco, 2005/04/16, compilazione
- Pizzo Marco, 2006/03/15, aggiornamento