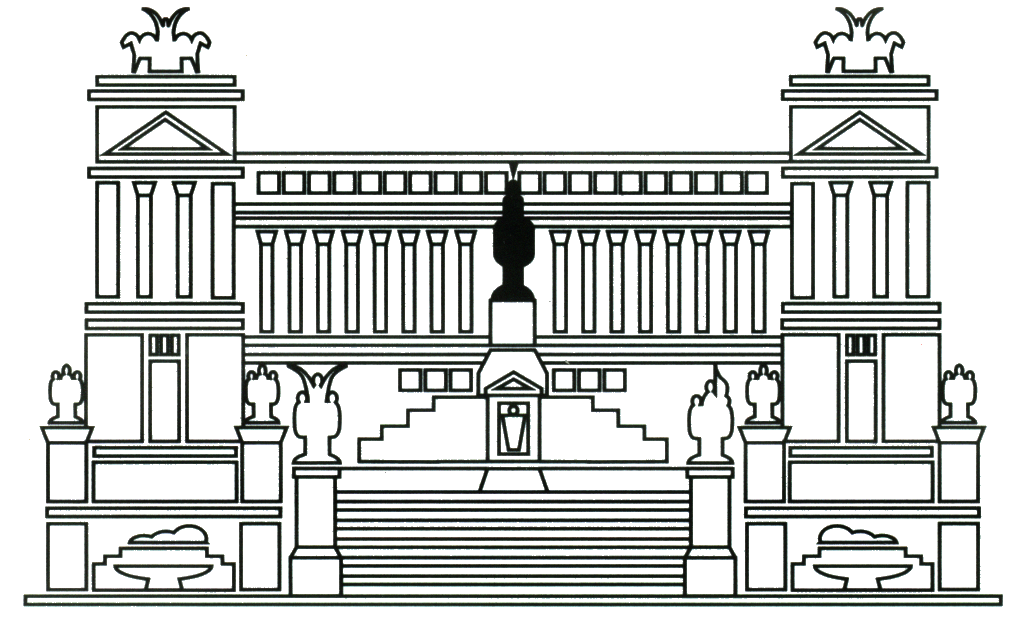Titolo originale:
Fondo Documenti 1866Tipologia:
fondoData:
(s.d.)Consistenza:
[non specificata]Descrizione:
Il fondo denominato “Documenti 1866”, conservato presso il Museo Centrale del Risorgimento di Roma, concentra in 7 buste (n.: 211-217) per una consistenza di 954 unità, telegrammi e minute tra i vari organi del governo italiano e lo stato maggiore dell’esercito nelle settimane in cui la terza guerra d’indipendenza entrava nella sua fase culminante e finale: tra l’ 11 luglio 1866 e il 20 febbraio 1867.I documenti raccolti sono in gran parte relativi alla corrispondenza del Ministero degli Interni, rappresentato sulle carte molto spesso da Celestino Bianchi, Segretario generale, essendo lontano da Firenze Bettino Ricasoli, Presidente del Consiglio e titolare ad interim degli Interni, trasferitosi a Ferrara nelle settimane del conflitto.
Particolarmente interessanti risulta la ricca collezione di informative dalle varie prefetture d’Italia, che testimoniano quasi quotidianamente dello stato d’animo della popolazione nelle varie fasi della guerra e delle trattative di pace, come nei resoconti allarmati riguardo le continue agitazioni di piazza dopo la sconfitta di Lissa del 20 luglio 1866.
Nel fondo è conservata la minuta a firma di Bettino Ricasoli di un progetto di armistizio inviato poi all’esame di Bismarck (MCRR b. 213, f. 11, 1-2). La sua lettura getta luce sulle aspirazioni del governo italiano che per Trieste e l’Istira proponeva le neutralizzazioni, mentre oltre al Veneto rivendicava anche il Trentino. Proposte rifiutate dal cancelliere tedesco come illustrato nel telegramma di Barral, ministro d’Italia e Govone, 27 luglio 1866 (MCRR b. 213, f. 54, 1).
Dell’attività diplomatica dell’inviato francese a Ferrara Girolamo Bonaparte, rimane un unico telegramma diretto al Ministro di Francia a Firenze, 28 luglio 1866 (MCRR b. 213, f. 76, 1).
Nel fondo infine si possono segnalare: copia di telegramma di Otto Bismarck-Schönhausen al Ministro di Prussia a Firenze, Berlino, 6 agosto 1866 (MCRR b. 215, f. 24, 1); proclama di Giuseppe Garibaldi indirizzato ai Trentini, senza luogo ne data (MCRR b. 212, f. 57, 2a).
Storia archivistica:
La cosiddetta Terza Guerra d’Indipendenza, iniziata il 19 giugno 1866, trova la sua origine l’8 aprile dello stesso anno, quando dopo lunghissime ed altalenanti trattative, Italia e Prussia avevano stipulato un trattato segreto di amicizia e di alleanza (cfr.: Lill Rudolf, L’ alleanza italo-prussiana, in Atti del XLIII congresso di storia del Risorgimento italiano(Venezia, 2 – 5 ottobre 1966), Roma, 1968, pp.:91-98). Questo stabiliva che nel caso la Prussia avesse dato avvio ad un conflitto con l’Austria, l’Italia era obbligata anch’essa a dichiarare guerra alla monarchia asburgica (art.: 2). Stabiliva inoltre che in caso di vittoria all’Italia sarebbe stato ceduto il Veneto. Il trattato rimaneva in vigore solo tre mesi.Allo scoppio delle ostilità Alfonso La Marmora lasciò a Bettino Ricasoli la Presidenza del Consiglio per assumere il comando supremo dell’esercito. Nel nuovo governo, Ricasoli assunse l’interim per il Ministero dell’Interno e fino al 28 giugno 1866, quando gli successe Emilio Visconti Venosta, anche quello degli Affari Esteri. Al ministero della Guerra Ignazio di Pettinengo de Genova (cfr.: Missori Mario, Governi, alte cariche dello stato, alti magistrati e prefetti del Regno d’Italia, Roma 1989, pp.:39-40).
Non essendo riusciti a stabilire un coordinamento nei piani strategici, i due eserciti italiano e prussiano agirono indipendentemente per tutto il corso della guerra. In Italia poi, divergenze di vedute ed incomprensioni personali tra La Marmora, comandante supremo dell’ esercito e allo stesso tempo comandante della prima armata, e Cialdini, comandante della seconda armata compromisero fin dall’ inizio le operazioni militari. Si arrivò così alla sconfitta di Custoza del 24 giugno, mentre il 3 luglio l’esercito prussiano riportava la decisiva vittoria di Koniggratz, vittoria che spinse il governo austriaco a chiedere la mediazione della Francia dichiarandosi anche favorevole alla cessione del Veneto. Nei giorni seguenti, Bismarck iniziò fertili trattative con Austria e Francia, senza informare l’alleato, solo quando si era prossimi alla conclusione, il 20 luglio mandò una nota dettagliata al governo italiano, che però pervenne a destinazione solo il 23. Nel frattempo il 20 luglio la flotta italiana subì la sconfitta di Lissa.
Il 27 luglio, pressato dalla Francia, Bismarck firma a Nikolsburg l’armistizio e i preliminari di pace con l’Austria. Anche il governo italiano nel frattempo aveva preparato un programma di armistizio, che però era gia stato ampiamente superato nei contenuti quando il 26 luglio fu presentato a Bismarck dal generale Covone.
Il 23 agosto fu firmato a Praga il trattato di pace austro-prussiano che all’art. 2 regolava la cessione di Venezia all’Italia.
La cosiddetta Terza Guerra d’Indipendenza, iniziata il 19 giugno 1866, trova la sua origine l’8 aprile dello stesso anno, quando dopo lunghissime ed altalenanti trattative, Italia e Prussia avevano stipulato un trattato segreto di amicizia e di alleanza (cfr.: Lill Rudolf, L’ alleanza italo-prussiana, in Atti del XLIII congresso di storia del Risorgimento italiano(Venezia, 2 – 5 ottobre 1966), Roma, 1968, pp.:91-98). Questo stabiliva che nel caso la Prussia avesse dato avvio ad un conflitto con l’Austria, l’Italia era obbligata anch’essa a dichiarare guerra alla monarchia asburgica (art.: 2). Stabiliva inoltre che in caso di vittoria all’Italia sarebbe stato ceduto il Veneto. Il trattato rimaneva in vigore solo tre mesi.
Allo scoppio delle ostilità Alfonso La Marmora lasciò a Bettino Ricasoli la Presidenza del Consiglio per assumere il comando supremo dell’esercito. Nel nuovo governo, Ricasoli assunse l’interim per il Ministero dell’Interno e fino al 28 giugno 1866, quando gli successe Emilio Visconti Venosta, anche quello degli Affari Esteri. Al ministero della Guerra Ignazio di Pettinengo de Genova (cfr.: Missori Mario, Governi, alte cariche dello stato, alti magistrati e prefetti del Regno d’Italia, Roma 1989, pp.:39-40).
Non essendo riusciti a stabilire un coordinamento nei piani strategici, i due eserciti italiano e prussiano agirono indipendentemente per tutto il corso della guerra. In Italia poi, divergenze di vedute ed incomprensioni personali tra La Marmora, comandante supremo dell’ esercito e allo stesso tempo comandante della prima armata, e Cialdini, comandante della seconda armata compromisero fin dall’ inizio le operazioni militari. Si arrivò così alla sconfitta di Custoza del 24 giugno, mentre il 3 luglio l’esercito prussiano riportava la decisiva vittoria di Koniggratz, vittoria che spinse il governo austriaco a chiedere la mediazione della Francia dichiarandosi anche favorevole alla cessione del Veneto. Nei giorni seguenti, Bismarck iniziò fertili trattative con Austria e Francia, senza informare l’alleato, solo quando si era prossimi alla conclusione, il 20 luglio mandò una nota dettagliata al governo italiano, che però pervenne a destinazione solo il 23. Nel frattempo il 20 luglio la flotta italiana subì la sconfitta di Lissa.
Il 27 luglio, pressato dalla Francia, Bismarck firma a Nikolsburg l’armistizio e i preliminari di pace con l’Austria. Anche il governo italiano nel frattempo aveva preparato un programma di armistizio, che però era gia stato ampiamente superato nei contenuti quando il 26 luglio fu presentato a Bismarck dal generale Covone.
Il 23 agosto fu firmato a Praga il trattato di pace austro-prussiano che all’art. 2 regolava la cessione di Venezia all’Italia.
La cosiddetta Terza Guerra d’Indipendenza, iniziata il 19 giugno 1866, trova la sua origine l’8 aprile dello stesso anno, quando dopo lunghissime ed altalenanti trattative, Italia e Prussia avevano stipulato un trattato segreto di amicizia e di alleanza (cfr.: Lill Rudolf, L’ alleanza italo-prussiana, in Atti del XLIII congresso di storia del Risorgimento italiano(Venezia, 2 – 5 ottobre 1966), Roma, 1968, pp.:91-98). Questo stabiliva che nel caso la Prussia avesse dato avvio ad un conflitto con l’Austria, l’Italia era obbligata anch’essa a dichiarare guerra alla monarchia asburgica (art.: 2). Stabiliva inoltre che in caso di vittoria all’Italia sarebbe stato ceduto il Veneto. Il trattato rimaneva in vigore solo tre mesi.
Allo scoppio delle ostilità Alfonso La Marmora lasciò a Bettino Ricasoli la Presidenza del Consiglio per assumere il comando supremo dell’esercito. Nel nuovo governo, Ricasoli assunse l’interim per il Ministero dell’Interno e fino al 28 giugno 1866, quando gli successe Emilio Visconti Venosta, anche quello degli Affari Esteri. Al ministero della Guerra Ignazio di Pettinengo de Genova (cfr.: Missori Mario, Governi, alte cariche dello stato, alti magistrati e prefetti del Regno d’Italia, Roma 1989, pp.:39-40).
Non essendo riusciti a stabilire un coordinamento nei piani strategici, i due eserciti italiano e prussiano agirono indipendentemente per tutto il corso della guerra. In Italia poi, divergenze di vedute ed incomprensioni personali tra La Marmora, comandante supremo dell’ esercito e allo stesso tempo comandante della prima armata, e Cialdini, comandante della seconda armata compromisero fin dall’ inizio le operazioni militari. Si arrivò così alla sconfitta di Custoza del 24 giugno, mentre il 3 luglio l’esercito prussiano riportava la decisiva vittoria di Koniggratz, vittoria che spinse il governo austriaco a chiedere la mediazione della Francia dichiarandosi anche favorevole alla cessione del Veneto. Nei giorni seguenti, Bismarck iniziò fertili trattative con Austria e Francia, senza informare l’alleato, solo quando si era prossimi alla conclusione, il 20 luglio mandò una nota dettagliata al governo italiano, che però pervenne a destinazione solo il 23. Nel frattempo il 20 luglio la flotta italiana subì la sconfitta di Lissa.
Il 27 luglio, pressato dalla Francia, Bismarck firma a Nikolsburg l’armistizio e i preliminari di pace con l’Austria. Anche il governo italiano nel frattempo aveva preparato un programma di armistizio, che però era gia stato ampiamente superato nei contenuti quando il 26 luglio fu presentato a Bismarck dal generale Covone.
Il 23 agosto fu firmato a Praga il trattato di pace austro-prussiano che all’art. 2 regolava la cessione di Venezia all’Italia.
Note:
BIBLIOGRAFIAR. Lill, L’ alleanza italo-prussiana, in Atti del XLIII congresso di storia del Risorgimento italiano(Venezia, 2 – 5 ottobre 1966), Roma, 1968, pp.:91-98
M. Missori, Governi, alte cariche dello stato, alti magistrati e prefetti del Regno d’Italia, Roma 1989, pp.:39-40
Redazione e revisione:
- Pizzo Marco, 2005/04/16, compilazione
- Pizzo Marco, 2006/03/07, aggiornamento