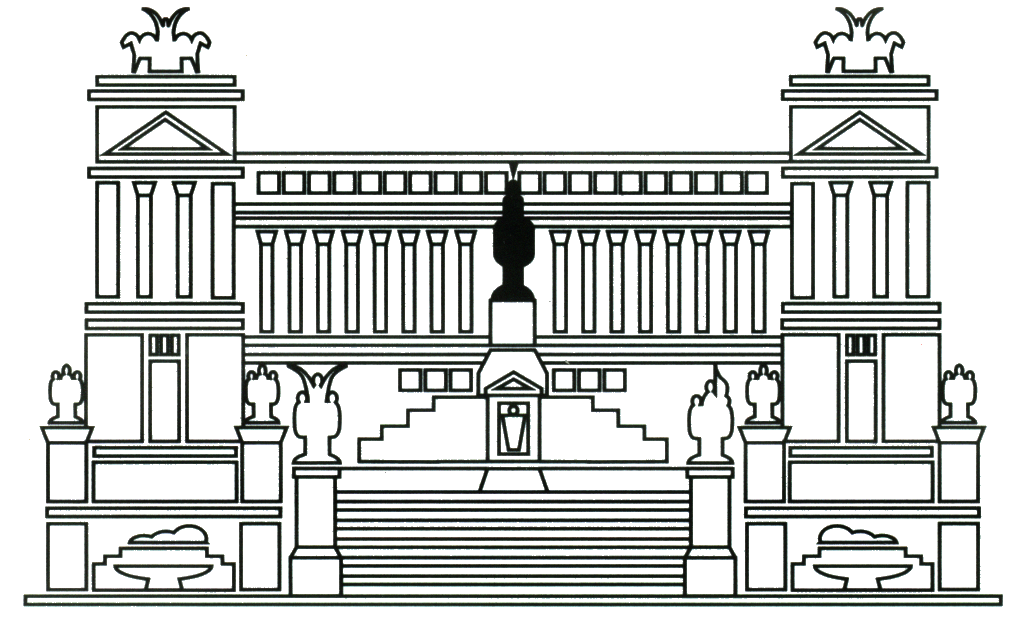Titolo originale:
Fondo Ferrari E.Tipologia:
fondoData:
(s.d.)Consistenza:
2Descrizione:
Il Fondo Ettore Ferrari conservato nel Museo Centrale Risorgimento di Roma è solo una parte del ricco archivio Ferrari, attualmente disperso in molte sedi. Altri documenti si conservano presso l’Archivio centrale dello Stato, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna, l’Archivio Storico del Grande Oriente d’Italia.Le carte di cui ci occupiamo sono pervenute al Museo Centrale del Risorgimento di Roma in data 8 novembre 1974 per acquisto da Salvatore Fadda, uno stracciarolo che si era occupato dello sgombero dello studio di scultore di Ettore Ferrari (cfr. E. Morelli, Alcune carte di Ettore Ferrari, I fondi archivistici del Museo Centrale del Risorgimento, pp. 297-298; cfr. anche quanto riportato dall’A. in merito alle dispersioni subite dalle carte in possesso del Fadda). Esse si conservano nelle bb. 962 e 963. Si tratta di 542 documenti, 42 stampati, 5 disegni ed un manoscritto, risalenti agli anni tra il 1866 e il 1926.
All’interno della documentazione è possibile riconoscere due nuclei documentari, probabilmente frutto dell’ordinamento dato alla carte dopo l’acquisizione da parte dell’ente in cui sono attualmente conservate. Il primo blocco, conservato nella b. 962, è costituito dalla corrispondenza personale del Ferrari. Si tratta in massima parte di lettere ricevute dallo scultore romano, suddivise in base al mittente. Nella b. 963 sono custodite corrispondenza in cui il Ferrari non compare né come mittente né come destinatario, ma relativa comunque a personaggi legati allo scultore romano in relazione alla sua attività politica, documentazione diversa relativa a circoli e associazioni di cui il Ferrari faceva parte, suoi autografi legati a vari argomenti, soprattutto ai suoi interessi artistici.
Per quello che riguarda la corrispondenza conservata nella b. 962, essa si rivela di particolare interesse, mostrando i rapporti epistolari dell’artista romano con personaggi legati alla sua area politica o alla massoneria. Tra i suoi corrispondenti segnaliamo Giovanni Bovio, filosofo della democrazia repubblicana, (MCRR, b. 963, F. 5, docc. 1-15, 6 maggio 1885-17 giugno 1902), Felice Cavallotti, altro esponente dell’estrema sinistra, acerrimo avversario del Depretis e del Crispi (MCRR, b. 962, docc. 1-12, 3 novembre 1890-19 ottobre 1894), Adriano Lemmi, mazziniano, già finanziatore della spedizione di Sapri,eletto Gran Maestro della massoneria nel 1885 (MCRR, b. 962, f. 16, docc. 1-18, 4 agosto 1883-12 ottobre 1904), Alberto Mario, altro mazziniano (MCRR, b. 962, f. 17, doc. 1, 21 agosto 1881, lettera relativa ad una riunione da tenersi per la formazione di un circolo anticlericale nel Rione Trevi in Roma). Il carteggio più cosicuo è però quello con Ernesto Nathan, sindaco di Roma, altro Gran Maestro della massoneria (carica che rivestì dal 1897 al 1904, poi dal 1917 al 1919). Si conservano 64 lettere, datate dall’11 febbraio 1891 al 9 luglio 1905 (MCRR, ff. 20-23).
Più legata a motivi d’occasione e agli interessi culturali del Ferrari appare la corrispondenza con Ersilia Caetani Lovatelli, archeologa, una fra le più interessanti figure di intellettuali nella Roma di fine Ottocento (MCRR, b. 962, f. 7, docc. 1-19, 17 agosto 1895-17 maggio 1905) e Caterina Ninetta Iovini (MCRR, b. 962, f. 15, docc. 1-9, 19 luglio-28 settembre 1901; alla lettera di cui al doc. 7 è allegato (doc. 7a) un manoscritto contenente due racconti della Iovini, uno dei quali datato 7 maggio 1899, l’altro 5 settembre 1901). Si conserva anche una lettera del pittore Domenico Morelli relativa ad un quadro del Ferrari acquistato per iniziativa del Vannutelli dalla Galleria Nazionale d’Arte Moderna (MCRR, b. 962, f. 19, 17 febbraio 1892). Alla Commissione Direttiva delle Scuole di disegno del Comune di Roma sono invece legate le lettere inviate al Ferrari da Oreste Palazzi (MCRR, b. 962, f. 25, doc. 1-10, 15 maggio 1903-8 giugno 1905) e dal Vecchini Papini (MCRR, b. 962, f. 38, doc. 1-10, 11 marzo 1904-10 aprile 1907, alcune lettere riportano le intestazioni della Direzione dei servizi amministrativi storici e artistici del Comune di Roma e della Scuola preparatoria alle arti ornamentali, sempre alla dipendenze del Comune capitolino).
Il nucleo archivistico più coerente conservato nella b. 962 è quello relativo alle elezioni svolte nella 2. congregazione umbra, svoltesi in seguito alla morte del deputato Massari e che videro il candidato democratico Edoardo Pantano, futuro ministro dell’Agricoltura, opposto ad Augusto Lorenzini. Si tratta in gran parte di corrispondenza inviata al Ferrari da diverse località del collegio in questione, evidentemente, almeno in parte, da personalità locali legate ai democratici (MCRR, b. 962, ff. 39-66, marzo-aprile 1884, con documenti successivi). Tra le lettere conservate spiccano quelle inviate dal comitato per l’elezione del Pantano in Rieti (MCRR, b. 962, f. 32, doc. 4, 9 aprile 1884, b, 962, f. 39, doc. 7, aprile 1884; in una lettera di Giovanni Trinchi si conserva un elenco dei membri del comitato in questione, cfr. MCRR, b. 962, f. 63, doc. 4, aprile 1884) e i telegrammi e le missive diretti al Ferrari da Domenico Benedetti Roncalli (MCRR, b. 962, f. 39, docc. 10-12, 21, 18, 14-21 aprile 1884; f. 60, docc. 1-16, 15 marzo-21 aprile 1884; le lettere di cui ai docc. 17 e 18 risalgono all’anno 1903; nel f. 39, doc. 23 si conserva l’esemplare diretto al Ferrari di un non meglio precisato comitato di Foligno relativo alla commemorazione del Roncalli, morto il 29 maggio 1910, cfr. MCRR, b. 962, f. 39, doc. 23, 10 aprile 1911).
Per quello che riguarda la b. 963, essa comprende, come accennato, corrispondenza in cui il Ferrari non compare né come mittente né come destinatario (cfr. MCRR, b. 963, ff. 2-9). Tra le lettere conservate vorremmo citare, a testimonianza della pertinenza della documentazione alla sfera della democrazia repubblicana, quelle dirette da Agostino Bertani a Ernesto Nelli, segretario del Comitato Nazionale per il Suffragio universale (MCRR, b. 963, f. 4, docc. 1-2, 13-17 gennaio 1881). Ancor più esemplari a proposito delle idee democratiche del Ferrari sono le carte relative a diverse associazioni legate alla sua stessa area politica. La documentazione più cospicua al proposito è costituita da quella relativa all’Associazione Repubblicana dei diritti dell’uomo, con sede in Roma, in relazione alla quale si conservano una bozza relativa alla costituzione del sodalizio (MCRR, b. 963, f. 1, doc. 1), una copia a stampa dello statuto (MCRR, b. 963, f. 1, doc. 1), numerosi fogli di presenza (con relative firme) a numerose adunanze dell’Associazione (MCRR, b. 963, f. 1, docc. 10, 11, 13-21, 5 aprile 1878-19 maggio 1879), la proposta di un ordine del giorno presentato in ooccasione di una riunione del sodalizio (MCRR, b. 963, f. 12, doc. 5, s. d.), e il risultato di una votazione del comitato esecutivo (MCRR, b. 963, f. 12, doc. 7, s. d.). Si segnalano anche, sempre in riferimento a sodalizi repubblicani, copia di un elenco di soci del Circolo Radicale di Roma (MCRR, b. 963, f. 12, doc. 6, s.d.) e una circolare del Comitato permanente per il Suffragio universale in Roma diretta ai “Comitati dei comizi pel suffragio universale” e “alle Associazioni operaie e politiche d’Italia” (MCRR, b. 963, f. 11, doc. 3, 27 ottobre 1880).
Interessanti sono anche alcuni documenti a stampa conservati nei ff. 11-13, insieme a documenti manoscritti. Tra questi vorremmo citare una lettera del Nathan scritta a propria difesa in merito alle rimostranze del pontefice contro un discorso pronunciato il 20 settembre 1910 in occasione del 40° anniversario della breccia di Porta Pia (MCRR, b. 962, doc. 13, 24 settembre 1910), due volantini, il primo di protesta contro il governo da parte della Federazione nazionale pro suffragio femminile, il secondo relativo alla pubblicità del film Dalle Cinque Giornate alla Breccia di Porta Pia (MCRR, b. 963, f. 11, docc. 17, 18, s. d.). All’appartenenza del Ferrari alla massoneria è invece da riferire un esemplare di una circolare, a firma, in qualità di Gran Maestro, dallo stesso artista romano, del Grande Oriente della Massoneria d’Italia “a tutte le Loggie della Comunione Italiana” (MCRR, b. 963, f. 11, doc. 12, 10 novembre 1910). Sempre a stampa sono le bozze di alcuni articoli di Alberto Mario (cfr. MCRR, b. 963, f. 15, docc. 1-8).
Altro nucleo documentario relativo alle carte Ferrari del Museo Centrale del Risoirgimento di Roma è quello relativo ai suoi autografi. Essi sono suddivisi tra 5 fascicoli e comprendono alcuni suoi schizzi (MCRR, b. 963, f. 17, docc. 1-5), autografi diversi, tra i quali racconti, saggi, discorsi, semplici appunti (MCRR, b. 963, f. 18, docc. 1-26), componimenti in versi, in parte incompiuti, scritti, almeno in parte, a giudicare da una camicia conservata nel fascicolo, “in Civita Vecchia nell\'Estate 1869” (MCRR, b. 963, f. 19, docc. 1-81; uno dei brani poetici è nel verso di un foglio con istanza presentata dal Ferrari per poter disegnare “alcuni oggetti esistenti nel Museo del Palazzo del Laterano\", cfr. doc. 11.), altri componimenti in versi a stampa conservati insieme ad un dramma di Emilio V. Banterle dedicato allo stesso Ferrari, dal titolo Il figlio legittimo, anch’esso a stampa (MCRR, b. 963, f. 20, docc. 1-4), autografi su questioni artistiche. Tra essi vorremmo citare uno scritto su un bassorilievo dello scultore messinese L. Gangeri (MCRR, b. 963, f. 21, doc. 12), un appello redatto anche a nome di altri artisti per lo svolgimento di una mostra di belle arti da tenersi in Roma a cadenza biennale, una memoria sulla necessità di istituire in Roma una “Mostra artistica italiana” (MCRR, b. 963, f. 21, doc. 7). Su quest’ultimo argomento si conservano altri documenti, posti in una camicia originale con intestazione “Discorsi e proposte fatte all’Associazione Artistica Internazionale”. Ricordiamo una “Premessa agli “articoli preliminari” del regolamento di una progettata “Mostra Artistica Italiana” , una minuta del Ferrari sull\'istituzione in Roma di una “Mostra Artistica annuale – Nazionale” su iniziativa dell\'Associazione Artistica Internazionale di Roma e della Società Amatori e Cultori di Belle Arti (cfr. MCRR, b. 963, f. 22, dcc. 2-3). Ad argomenti artistici e ad associazioni sull’arte si riferisce anche la documentazione conservata nel f. 23, che include documenti relativi all’Associazione Nazionale Insegnanti Disegno, tra cui esemplari di Bollettini locali (in particolare della sezione sicula, di quella lombarda e di quella di Sassari), un opuscolo a cura della già citata Associazione Artistica Internazionale in Roma inerente ad una “Mostra del paesaggio italiano” prevista per la primavera 1926, con relativo regolamento (cfr. MCRR, b. 963, f. 23, doc. 19, 25 dicembre 1925), un invito della stessa Associazione ad una conferenza di Pietro Gongolini sul tema “Mussolini e l\'arte” (MCRR, b. 963, doc. 20, a. 1926), la bozza di un saggio del mosaicista Antonio Salviati sullo scrittore Tullio Dandolo (MCRR, b. 963, doc. 21, s. d.), un opuscolo a stampa con statuto dell\'Istituto di Belle Arti di Roma e relativo Regio Decreto di approvazione del 3 dicembre 1876 (MCRR, b. 963, f. 23, doc. 5, 21 dicembre 1876), un altro opuscolo a stampa con regolamento dell’ “Esposizione di Belle arti in Roma 1882-83” (MCRR, b. 963, f. 23, doc. 6). La documentazione conservata nella b. 963 si chiude infine con numerose ricevute rilasciate al Ferrari, soprattutto per versamenti di quote sociali e di abbonamenti a riviste e giornali (cfr. MCRR, b. 963, f. 24).
Storia archivistica:
Ettore Ferrari nacque a Roma il 25 marzo 1845 da Filippo (Filippo Ferrari, nato a Roma il 25 febbraio 1814, carbonaro e repubblicano, partecipò alla difesa della Repubblica Romana nel 1849. Intraprese la carriera artistgica come scultore e incisore, sotto la guida di uno zio paterno. Isolato a causa delle sue idee politiche, solo verso la fine degli anni Cinquanta ottenne delle commesse al cimitero del Verano. Tra le sue opere le statue di Apollo e Fidia collocate sulla terrazza del Palazzo delle Esposizioni di Roma nel 1884. Morì a Roma il 30 gennaio 1897) e da Maria Luisa Pasini. Fu il padre, portatore di idee repubblicane, a provvedere alla sua formazione intellettuale. Attivo nel comitato d’azione mazziniano di Roma, prese parte al fallito tentativo insurrezionale del 22 ottobre 1867. Seguì corsi di lettere e giurisprudenza presso l’Università di Roma e fu membro dell’Accademia dell’Arcadia. Sulle orme del padre intraprese la carriera artistica, che lo vide attivo come pittore e scultore. Dopo la caduta del potere temporale, ebbe inizio per il Ferrari una lunga attività di uomo politico, come rappresentante della Sinistra democratica. Nel 1877 fu eletto per la prima volta consigere comunale di Roma, carica che ricoprì, con intervalli, fino al 1907, occupandosi prevalentemente di problemi legati ai suoi interessi artistici, dalla costruzione del palazzo delle Esposizioni alla proposta di monumenti celebrativi. Nel 1880 sposò Maria Carolina Frey von Freienstein, figli del pittore svizzeo, J. J. Frey, da cui ebbe due figli, Gian Giacomo e Giordano Bruno. Nel 1879 prese parte ai lavori preparatori che portarono alla fondazione della Lega della Democrazia.Il 29 ottobre 1882 venne eletto deputato nel collegio di Perugia II (Spoleto), venendo confermato nella XVI Legislatura (elezioni del 23 maggio 1886) e nella XVII (elezioni del 23 novembre 1890). La sua attività di parlamentare, poco rilevante durante la XV Legislatura, divenne più incisiva nei mandati successivi. Legato alla democrazia francese, fu avversario del Crispi. Combattè la politica coloniale del governo, opponendosi alla nascita della colonia eritrea. Osteggiò inoltre la Triplice Alleanza. Il 1 maggio 1891 partecipò al comizio operaio a S. Croce in Gerusalemme, che sfociò in gravi incidenti, sui quali il Ferrari intervenne in Parlamento accusando le forze di polizia di provocazione e precisando che le associazioni operaie e democratiche di Roma avevano organizzato il comizio per celebrare la Festa del Lavoro ed esprimere la propria solidarietà con i lavoratori di tutto il mondo.
Nella sua cinquantennale presenza sulla scena politica romana, il Ferrari operò soprattutto al fine di favorire il dialogo tra le forze progressiste. Legato politicamente a Felice Cavallotti, fu tra gli organizzatori del congresso di Roma dell’11-13 maggio 1890, che si concluse con il cosiddetto “Patto di Roma”, sottoscritto da radicali, da alcuni socialisti, da irredentisti e repubblicani. Fu un momento importante nella storia della democrazia radicale, attuandosi la sintesi dei programmi delle singole componenti.
Nelle elezioni politiche dello stesso anno il Ferrari fu coinvolto nello scandalo del finanziamento di 100.00 lire versaro da E. Cernuschi ai democratici cavallottiani, che l’opposizione sfruttò per una campagna di accuse di tradimento e di asservimento alla democrazia francese.
Accanto alla militanza ufficiale tra i repubblicani, lo scultore fece parte della carboneria romana e dell’Alleanza repubblicana universale (ARU), il cui scopo era quello di mantenere vivo l’ideale repubblicano rivoluzionario.
Il 31 marzo 1896 fu chiamato a far parte del comitato eletto dalle associazioni repubblicane romane allo scopo di riorganizzare il partito repubblicano nel Lazio. Il 20 settembre 1896 fu convocato a Roma un congresso che riassunse le conclusioni del comitato stabilendo le linee-guida dell’azione del partito: associazionismo di stampo collettivista, abbandono dell’astensionismo elettorale, dialogo con i socialisti. Su questa base programmatica si costituì, il 29 novembre dell’anno in questione, la Consociazione repubblicana del Lazio. Il congresso si svolse nel grande studio del Ferrari presso Porta Salaria, che fu sede di altre iniziative. Il 18 febbraio 1894 ospitò un convegno democratico, nel corso del quale fu condannata la repressione dei Fasci siciliani e fu progettata l’unione delle sinistre in funzione anti-crispina. Nel 1897 vi fu organizzata la spedizione garibaldina in Grecia. Vi si svolgevano anche le riunioni segrete dell’ARU.
Il 7 giugno 1898, a seguito dei provvedimenti repressivi decisi dal governo di Rudinì, vennero sciolti la Consociazione Repubblicana del Lazio e i circoli ad essa aderenti. Già nell’autunno di quell’anno si intraprese, in casa del Ferrari, la riorganizzazione delle forze repubblicane. Dal 1899 al 1900 l’artista romano fu membro del Comitato centrale del partito repubblicano, di cui conservò sempre la tessera. Nel 1901 fu candidato nel IV collegio di Roma, venendo sconfitto dal principe Torlonia. Nel 1901 presiedette il congresso annuale del partito. Da quel momento cominciò a defilarsi dalla scena politica, dedicandosi alla massoneria.,alla quale era stato iniziato nell’estate del 1881 nella loggia “Rienzi” diRoma su proposta di U. Bacci. Fu gran segretario del garn maestro Adraino Lemmi, poi di Ernesto Nathan, cui fu sempre legato. Nel 1900 fu eletto gran maestro aggiunto. Il 15 febbraio 1904 fu eletto gran maestro del Grande Oriente d’Italia, imprimendo un’impronta democratica e anticlericale, e insistendo per l’impegno a favore della precedenza del matrimonio civile e della legge sul divorzio e in quello per la scuola laica. Il Ferrari cercava di constrastare l’avanzata dei cattolici nella vita politica italiana, scontrandosi con coloro che invece preferivano prendere posizione a favore del mondo cattolico piuttosto che di quello socialista. Si giunse infine alla rottura che portò alla nascita della Gran Loggia di piazza del Gesù, guidata da S. Fera. Il tentativo del Ferrari di tenere unite le forze progressiste subì un duro colpo quando i socialisti, nel Congresso di Ancona del 1914, votarono l’incompatibilità della doppia iscrizione al partito e all’Ordine. La decisione si inquadrava nella campgna anti-massonica intrapresa dalle forze politiche emergenti, ossia cattolici, nazionalisti, socialisti, che fecero della guerra alla Massoneria un punto qualficante della propria azione, incrementando la polemica in concomitanza con le elezioni politiche del 1913. A difesa delle proprie posizioni, il Grande Oriente fondò un settimanale, L’idea democratica, affidandone la direzione a G. Bandini.
Allo scoppio della prima guerra mondiale, il Ferrari si proclamò interventista convinto, considerandola la quarta guerra per l’indipendenza. Nel 1917 partecipò al Congresso di Parigi, in cui le massonerie dell’Intesa, ad eccezione di quelle britanniche, si incontrarono allo scopo di elaborare un progetto di Società delle Nazioni. Le polemiche sollevate dal timore che la delegazione italiana votasse a favore del principio di autodeterminazione dei popoli costrinsero lo scultore a rimettere il mandato. Lasciata la gran maestranza, fu chiamato nel 1918 a ricoprire la carica di sovrano gran commendatore del Supremo Consiglio dei Trentatrè, carica che conservò sino alla morte. Nel 1919 fu nominato Gran Maestro onorario a vita e nello stesso anno rifiutò la nomina a senatore a vita. L’8 agosto 1922 morì l moglie Maria Carolina. A partire dalla fine del 1922 il Ferrari dedicò ogni suo sforzo a rinforzare il rito scozzese. L’istituzione si stava preparando a stringere le file per difendersi dagli attacchi fascisti, mentre si aprivano le porte ai fratelli del rito simbolico che rifluivano nel rito scozzese. La riforma Gentile spinse il Ferrari a ribadire che lo Stato non aveva competenza per l’istruzione religiosa. Per meglio divulgare il suo pensiero, l’artista romano diede vita ad una pubblicazione, Lux, che si occupava di questioni politiche ed esoteriche. Il Ferrari non sciolse il suo rito neanche dopo l’approvazione della legge del novembre 1925 contro le società segrete. Sorvegliato dalla polizia, fu denunciato il 25 maggio 1929, con l’accusa di aver tentato la riorganizzazione della massoneria, e sottoposto ad ammonizione. Era infatti in rapporti epistolari con G. Leti, avvocato e noto antifascista, emigrato in Francia, suo luogotenente, e al quale nel maggio 1929 trasmise i pieni poteri.
Morì a Roma il 19 agosto 1929.
Come scultore,. Il Ferrari esordì al concorso Albacini dell’Accademia di S. Luca nel 1868. Negli anni Settanta sperimentò una sorta di romanticismo storico personalizzato attraverso l’uso del lessico barocco, operazione apparentemente ritardataria, ma in realtà aggiornata sia all’ambiente romano, che solo dal 1870 si aprì al romanticismo storico, sia ai tempi stessi della scultura. Varie opere del periodo di frequenza dell’Accademia si rifanno a soggetti letterari. In questo perido (cfr. il Bruto del 1870) il Ferrari elabora il tema del ribelle, sul quale tornò costantemente nel corso della carriera. Nello Stefano Porcari maturò, attraverso una serie di disegni e bozzetti, i modelli formali che ne caratterizzeranno la statuaria monumentale. Gli inizi della professione furono difficili, forse anche a causa della sua fede repubblicana. La prima occasione di cimentarsi con la dimensione monumentale gli fu offerta nel 1875 dalla Romania, che gli commissionò un monumento dedicato al poeta Heliade Radulesco da erigersi a Bucarest e un Ovidio da collocare a Costanza (opere ultimate rispetivamente nel 1877 e 1879). Nel 1880 il Ferrari vinse il concorso per il monumento equestre a Vittorio Emanuele II a Venezia, inaugurato nel 1887. A partire da questo momento egli realizzò in varie città monumenti pubblici dedicati ai protagonisti del Risorgimento italiano, raggiungendo nelle opere più riuscite il “giusto equilibrio tra la rappresentazione storica del personaggio o dei fatti” e quella “allegorico-simbolica”. I monumenti cui è maggiormente legata la fama del Ferrari sono entrambi a Roma: il Giordano Bruno del 1887 eretto in Campo de’Fiori e il Giuseppe Mazzini (1902-1911, ma pensato già a partire dal 1890) sull’Aventino a Roma.
All’apice delle notorietà artistica, il F. rivestì importanti incarichi pubblici. Fece parte della Giunta superiore e del Consiglio per le Belle Arti dal 1882 al 1892. Dal 1896 fu titolare della cattedra di scultura preso il Regio Istituto di Belle Arti in Roma, del quale fu poi presidente a partire dal 1906.
Note:
M. Casella, Democrazia socialimo movimento operaio a Roma (1892-1894), Roma 1979.M. Casella, I repubblicani a Roma alla fine del secolo, in L’associazionismo mazziniano, Roma 1979, pp. 176-221.
F. Cordova, Agli ordini del serpente verde. La massoneria nella crisi del sistema giolittiano, Roma 1990.
Dizionario biografico degli Italiani, vol. XLVI, 1976, pp. 550-555.
A. Galante Garrone, Felice Cavallotti, Torino 1966.
A. M. Isastia, Le memorie di Ettore Ferrari sugli avvenimenti romani dell’autunno 1867, in “Archivio trimestrale”, VI (1980).
A. M. Isastia, Il progetto liberaldemocratico di Ettore Ferrari, Roma 1995.
A. M. Isastia, Ettore Ferrari, Ernesto Nathan e il congresso massonico del 1917 a Parigi, in Il Risorgimento, 1995.
E. Morelli, Alcune carte di Ettore Ferrari, in Idem, I fondi archivistici del Museo Centrale del Risorgimento
S. Miccolis, La figura di Ettore Ferrari e alcune lettere di G. Bovio, in “Archivio trimestrale”, IX (1983), pp. 37-56.
R. Rainero, L’anticolonialismo italiano da Assab ad Adua, Milano 1971.
L. Rossi, Ettore Ferrari politico, in Ettore Ferrari 1845-1929, a cura di B. Mantura-P. Rosazza-Ferrari., Milano 19
La documentazione è stata prodotta da:
Persone:
- Ferrari Ettore, autore
Redazione e revisione:
- Pizzo Marco, 2005/04/16, compilazione
- Pizzo Marco, 2006/03/07, aggiornamento