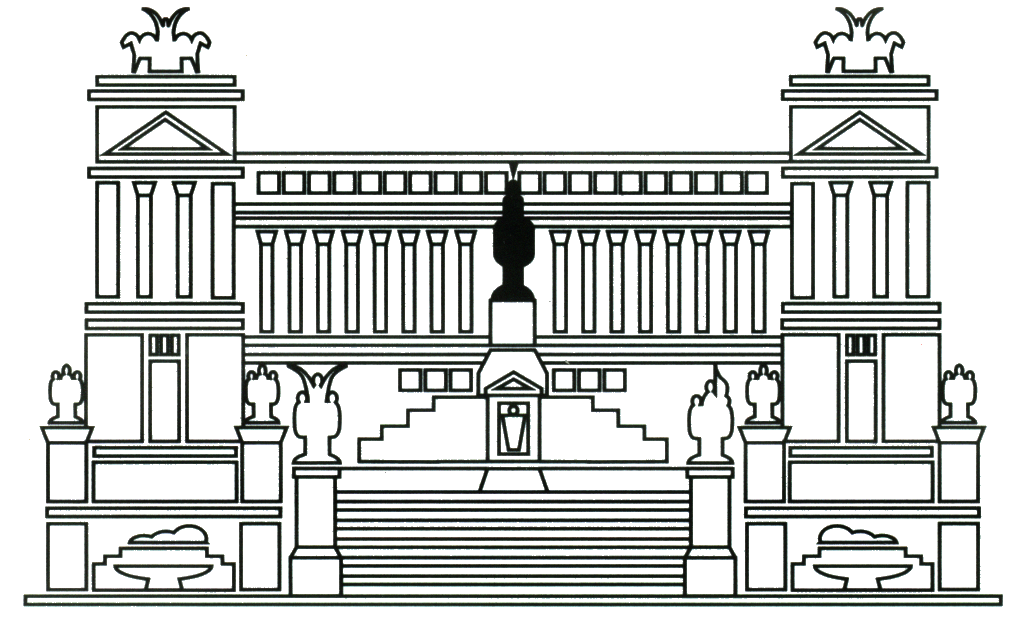Titolo originale:
Fondo RossettiTipologia:
fondoData:
(s.d.)Consistenza:
[non specificata]Descrizione:
Il fondo denominato “Carte Rossetti” conserva nelle buste 275-279 e 324-325 documenti legati alla figura di Gabriele Rossetti. Si tratta per la parte più consistente del suo epistolario, ordinato dal figlio William Michael con la probabile intenzione di pubblicarlo. Questo spiega la presenza accanto agli originali di numerose trascrizioni e traduzioni dall’inglese insieme a copie provenienti dal fondo conservato nel municipio di Vasto e da raccolte pubbliche e private (cfr.: Emilia Morelli, I fondi archivistici del Museo Centrale de Risorgimento, Roma, La Fenice edizioni, 1993, p. 133). Il materiale così preparato venne poi inviato a Domenico Ciampoli che lo integrò ulteriormente. Successivamente, nonostante le proteste degli eredi, la raccolta venne versata nel Fondo Risorgimento del Comitato Nazionale per la Storia del Risorgimento Italiano per poi trovare definitiva collocazione nell’attuale sede presso il Museo Centrale del Risorgimento di Roma.Le carte coprono un arco cronologico tra il 1807 e il 1910, per una consistenza di xxxx unità documentarie, anche se la parte più consistente si concentra tra il 1824 ed il 1853. Accanto alle sette buste della collezione documentaria si affiancano anche 22 volumi miscellanei (mms 192-213).
La parte più consistente del carteggio è quella intercorsa tra il 1826 ed il 1848 con Charles Lyell, amico e protettore di Rossetti, parte in originale parte in copia. Del periodo anteriore al 1824, anno della partenza da Napoli, rimangono solo alcuni esempi, mentre del soggiorno maltese può essere oggetto di curiosità la lettera dell’ottobre 1824 diretta al Console di Napoli per difendersi dall’accusa di essere un prete spretato (MCRR b.325, f.25, 1). Tra le carte dell’esilio londinese si possono ricordare due lettere di Mary Shelley, del 3 e del 20 aprile 1835 nelle quali la scrittrice chiede notizie sull’Alfieri per una biografia che intendeva scrivere (MCRR b.275, f.12, 1-2). Tra i corrispondenti italiani troviamo una lettera di Vincenzo Monti del 12 ottobre 1826 (MCRR b.278, f.39, 1), e i resoconti della vita politica e letteraria napoletana di Ferdinando Ciciloni (MCRR b.324, ff.10-11).
Numerosissime sono le lettere intercorse tra Rossetti con i figli e i familiari, tra cui il suocero Gaetano Polidori che lo aveva introdotto nell’ambiente letterario e culturale inglese.
Infine si conservano in copia anche 9 lettere di Giuseppe Mazzini, tra il 1841 e il 1848, (MCRR b.277, f.11; b.278, f.42) (gli originali sono passati nella Collezione Mazziniana, cfr.: Emilia Morelli, I fondi archivistici del Museo Centrale de Risorgimento, Roma, La Fenice edizioni, 1993, p. 135).
La busta 279, custodisce il manoscritto autografo della Vita mia – Il testamento, autobiografia in versi pubblicata postuma (MCRR b.279, f.1, ms.1), donato da Domenico Ciampoli, assieme a trascrizione di libretti d’opera, stampati e una piccola raccolta di fotografie e stampe (MCRR b.279, f.8) di ritratti di Gabriele Rossetti e di immagini familiari.
I 22 volumi miscellanei (mms. 192-207), rilegati assieme da William Michael Rossetti, raccolgono appunti, bozze manoscritte relative a diverse opere letterarie di Rossetti, in parte autografe in parte scritte sotto dettatura dai figli, soprattutto negli ultimi anni di vita del poeta. I volumi 208-213 ragruppano invece opere a stampa di vari autori, tra cui ricordiamo l’edizione a stampa (Genova 1852) de L’arpa evangelica, Genova 1852 con correzioni autografe di Rossetti.
Storia archivistica:
Gabriele Rossetti nasce il 28 febbraio 1783 a Vasto, in Abruzzo. Il marchese d’Avalos, comprese le sue precoci qualità intellettuali ed artistiche, lo invia a studiare presso l’Università di Napoli. Si trova ancora in questa città quando nel 1806, dopo la fuga di Ferdinando IV in Sicilia, Giuseppe Bonaparte si insedia sul trono dei Borboni. Dopo una breve esperienza come librettista per il teatro S.Carlo, Rossetti viene nominato conservatore dei marmi e bronzi antichi del Museo di Napoli, carica che ricoprirà per quindici anni. Dal novembre 1813 al maggio 1814 gli viene affidato l’incarico di segretario della sezione romana del governo provvisorio per l’Istruzione pubblica e le Belle arti. In questi anni ebbe rapporti di amicizia con Gioacchino Murat e i Bonaparte. Nel 1815, tornati al potere i Borboni, mantiene l’incarico nel suo ufficio pubblicando, col nome di Filidauro Labidiense, le sue poesie di carattere arcadico.Carbonaro sin dal 1812 prende parte agli avvenimenti del 1820 a Napoli per poi essere designato a celebrare con i suoi versi poetici la costituzione concessa da Ferdinando I. Ma l’anno successivo, abolita la costituzione e iniziata una dura repressione, Rossetti il 9 aprile è costretto ad abbandonare l’Italia rifugiandosi prima a Malta e poi a Londra nel 1824.
Nell’Inghilterra del XIX secolo, così devota verso la figura di Dante, Rossetti, profondo conoscitore e studioso del poeta fiorentino, trova presto nei circoli culturali un ambiente a lui favorevole e ben disposto. Nel 1826 sposa Francesca Polidori, da cui avrà quattro figli, tra cui il celebre pittore “preraffaellita” Dante Gabrile, e nel 1831 ottiene la cattedra di letteratura italiana al King’s College di Londra. Qui ha occasione di continuare le sua attività poetica e l’opera di critica dantesca iniziata a Malta.
Dal 1842 la sua salute inizia un lento declino, nel 1847 è costretto ad abbandonare l’insegnamento presso il King’s College, mentre dopo il fallimento dei moti del 1848 Rossetti rinuncia quasi definitivamente ad ogni speranza di poter ritornate in Italia. Ma come molti connazionali presenti a Londra, anche Rossetti rimane profondamente legato alla sua patria, e negli ultimi anni di vita collabora con il giornale “L’eco di Savonarola”, diretto dal connazionale Leonardo Mapei.
Gabriele Rossetti muore nella capitale inglese il 24 aprile 1854.
L’attività letteraria di Rossetti e ricordata principalmente per i saggi critici di tono antipapale e massonico: Commento analitico alla Divina Commedia, 1826-27; Sullo spirito antipapale che produsse la Riforma, 1832; La Beatrice di Dante 1842. Ma fu anche poeta lirico con una fervida vena religiosa e sentimentale: Odi cittadine, 1820; Iddio e l’uomo, 1833; Il Veggente in solitudine, 1846; L’arpa evangelica, 1852.
La documentazione è stata prodotta da:
Persone:
- Rossetti Dante Gabriele, autore
Redazione e revisione:
- Pizzo Marco, 2005/04/16, compilazione
- Pizzo Marco, 2006/03/07, aggiornamento