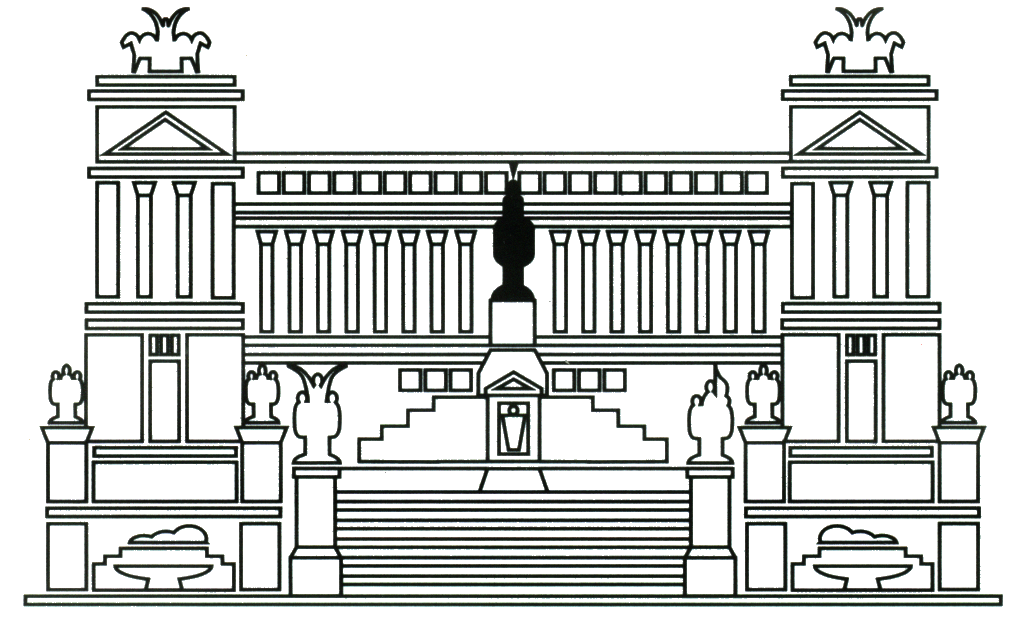Titolo originale:
Fondo SprovieriTipologia:
fondoData:
(s.d.)Consistenza:
8Descrizione:
Il fondo relativo a Francesco Sprovieri fa parte del Museo Centrale del Risorgimento di Roma fin dal 20 gennaio 1936, data nella quale venne depositato da Beatrice Sprovieri, figlia del patriota calabrese.Esso si conserva nelle bb. 503-510 e comprende 2256 documenti, 9 stampati e una fotografia, inerenti agli anni tra il 1848 e il 1899.
La documentazione comprende due corposi nuclei documentari, costituiti rispettivamente dalla corrispondenza privata dello Sprovieri, che include numerose lettere a lui indirizzate, e da documentazione inerente all’attività dei reparti al comando del patriota calabrese durante le Campagne del 1860 e 1866. Un terzo blocco di documenti è costituito dalle bozze relative all’autobiografia Ricordi politici e militari, pubblicata nel 1894 (cfr. MCRR, b. 510, f. 5, docc. 1-83, f. 6, docc. 1-656), da diari e memorie relative alla partecipazione dello Sprovieri alla difesa di Venezia e alle vicende che seguirono la sua partenza dalla città lagunare, fino all’arrivo a Genova (cfr. MCRR, b. 510, f. 1, docc. 1-15), da memorie sui viaggi effettuati a Parigi e in Svizzera negli anni 1851 e 1855 (cfr. MCRR, b. 510, f. 2, docc. 1-4) e sulla Campagna del 1859 (cfr. MCRR, b. 510, f. 3, docc. 1-3), da appunti vari, soprattutto di carattere biografico (cfr. MCRR, b. 510, f. 4, docc. 1-4).
Mentre il terzo nucleo da noi descritto si conserva all’interno di una stssa unità fisica, gli altri due risultano suddivisi in più blocchi, conservati in buste diverse.
Per quello che riguarda la corrispondenza personale dello Sprovieri, essa costituisce la totalità della documentazione attualmente conservata nelle bb. 504-506, e una parte delle carte incluse nella b. 508. Essa comprende lettere inviate al patriota calabrese da numerosi protagonisti del nostro Risorgimento. Le carte sono conservate in fascicoli relativi ciascuno ad un mittente, che si susseguono però senza un criterio preciso, come, ad esempio l’ordine alfabetico per mittente. Il carteggio più cospicuo è quello con Giovanni Nicotera, del quale si conservano ben 66 lettere inviate allo Sprovieri, comprese tra gli anni 1851 e 1894 (cfr. MCRR, b. 505, ff. 54-59). Altri corrispondenti dello Sprovieri furono, tra gli altri, Giuseppe Garibaldi, di cui si conservano 5 lettere a Francesco Sprovieri (MCRR, b. 506, f. 2, docc. 1-5, 16 febbraio 1862-23 agosto 1869) ed una a suo padre Michele (MCRR, b. 506, f. 1, doc. 1, 2 gennaio 1865), Oreste Baratieri, di cui si conservano 9 lettere (cfr. MCRR, b. 504, doc. 46, s.d.), Biagio Miraglia (5 lettere, MCRR, b. 504, f. 61, 16 dicembre 1860-27 aprile 1864), Antonio Greco (13 lettere, MCRR, b. 505, docc. 1-13, 21 marzo 1866-10 giugno 1879), Luigi Miceli (26 lettere, MCRR, b. 506, f. 49, docc. 1-13, f. 50, docc. 1-13, f. 51, docc. 1-6, 2 aprile 1863-15 aprile 1899). Numerose sono anche le lettere di Giovanni Battista Casareto, inviate in qualità di console dei “Caravana” della Regia Dogana e Deposito Franco di Genova, soprattutto in merito a vertenze che coinvolgevano il sodalizio (MCRR, b. 505, ff. 81-84, 6 marzo 1886-28 novembre 1898; della “compagnia” dei “Caravana” genovesi si conservano altre lettere, alcune delle quali legate a circostanze occasionali, come gli auguri di inizio anno, cfr. b. 508, f. 24, docc. 1-18, 1 gennaio 1888-1 gennaio 1899).
Le lettere del Casareto sono indirizzate allo Sprovieri in relazione alla carica di deputato, per poterne ottenere cioé l’interessamento nell’ambito delle vertenze suddette. Ciò ci introduce nell’ambito nel quale sono da inserire molte delle lettere ricevute dal garibaldino calabrese (oltre che di missive da lui inviate, tuttora conservate, insieme a lettere di diverso argomento, nella b. 506, ff. 16-38), relative ai suoi interventi per la concessione di impieghi, sussidi, sovvenzioni, lavori pubblici, onorificenze. Parte di questa documentazione, che non include solo corrispondenza, si conserva nella b. 508, ff. 16-27 (da citare in particolare le lettere indirizzate allo Sprovieri dalla Commissione dei Danneggiati Politici delle Province Napoletane istituita presso il Ministero dell\'Interno, di cui lui stesso fece parte, cfr. MCRR, b. 508, f. 23, docc. 1-14, 24 marzo 1894-6 dicembre 1898) insieme ed altri documenti riferibili ad argomenti precisi, e perciò riuniti anche fisicamente. Ricordiamo, a questo proposito, la corrispondenza che testimonia i rapporti del patriota calabrese con enti pubblici e associazioni operaie o patriottiche della sua regione (cfr. MCRR, b. 508, f, 28, 1886-1896), e che comprende lettere relative alla nomina a socio onorario delle stesse o alla delega a rappresentarle in occasione di pubbliche cerimonie, e la documentazione inerente al servizio prestato dallo Sprovieri nell’Esercito meridionale e nel Regio Esercito (cfr. MCRR, b. 508, ff. 29-30, 1861-1873, con istanze per la concessione di aspettative o richiami in servizio e di aumenti di pensione). A parte si conservano altri documenti estranei sia alla corrispondenza personale sia alle carte relative all’attività dei reparti di cui lo Sprovieri fu a capo nelle Campagne del 1860 e 1866. Si tratta in particolare di decreti e attestati relativi soprattutto alla carriera militare dello Sprovieri e alla sua partecipazione alla Campagne per l’indipendenza d’Italia (promozioni, collocamenti in aspettativa o a riposo, concessioni di onorificenze e medaglie, ecc., cfr. MCRR, b. 509, ff. 1-5) e delle relative lettere di trasmissione (che non si conservano più, dunque, con i documenti ad essi in origine allegati, cfr. MCRR, b. 509, f. 6). La documentazione in questione comprende anche bozze di discorsi (come uno relativo al richiamo delle truppe coloniali dall’Afirca, cfr. MCRR, b. 509, f. 7, in particolare il doc. 5, del giugno 1887), alcuni documenti relativi alla partecipazione dello Sprovieri alla difesa di Venezia (in particolare lettere di comunicazione di promozioni, lasciapassare, certificati di buon condotta, cfr. MCRR, b. 509, f. 10, docc. 1-9, 1848-1849) e alla Campagna del 1859 (corrispondenza, rapporti, cerificati vari, cfr. MCRR, b. 509, f. 11, docc. 1-17, 1959-1960).
L’accenno alle carte relative alle Campagne del 1848-1849 e del 1859 ci consente di introdurre il discorso sugli altri due grandi nuclei documentari che compongono il Fondo Sprovieri, ossia quelli formati dalla documentazione inerente all’attività dei reparti comandati dal patriota calabrese nelle successive Campagne del 1860 e 1866.
L’origine stessa della documentazione fa prevedere la presenza, all’interno delle carte, di numerose tipologie documentarie, legate alle diverse attività svolte da un reparto militare. In effetti, oltre alla corrispondenza, sono presenti rapporti, ordini di servizio, ordini del giorno, ruoli di militari appartenenti ad una determinata sezione, situazioni della forza, certificati ed attestati vari, documenti contabili, ecc.).
Per quello che riguarda la Campagna del 1860, le carte sono relative ad un battaglione al comando dello Sprovieri, ossia il II Battaglione della III Brigata dei Cacciatori delle Alpi, poi ridenominato, probabilmente dopo la costituzione dell’Esercito Meridionale (su cui cfr. MCRR, Fondo Cadolini, b. 458, f. 16, doc. 1, 19 luglio 1860) VI Battaglione della II Brigata (detta anche brigata De Milbitz dal nome del comandante), della divisione Cosenz (nel settembre 1860 fu poi creato, alla dipendenze sempre della brigata De Milbitz, il 5° Reggimento Sprovieri, su cui cfr. in particolare MCRR, b. 507, f. 8). La documentazione, che forma un blocco compatto che parte dal f. 1 della b. 507 fino al f. 15 della b. 508, non presenta a prima vista un ordine preciso, se non quello cronologico presente nei fascicoli, che comunque talvolta prosegue in quelli successivi, conferendo alle carte una organicità almeno parziale, che però non è chiaro se rispetti la sedimentazione originaria dei documenti.Sembra comunque che le carte siano state in gran parte suddivise in base alle tipologie documentarie, come testimonia la conservazione a parte delle situazioni della forza e dei ruoli (cfr. MCRR, b. 507, ff. 1-4), dei rapporti, ordini del giorno e certificati (cfr. MCRR, b. 507, ff. 1-19) e delle ricevute e buoni relativi alla fornitura di viveri, vestiario ed equipaggiamento, e più in generale all’amministrazione dei reparti al comando dello Sprovieri (cfr. b. 508, ff. 1-15).
Si conserva anche docunmentazione relativa allo scioglimento da parte dello Sprovieri della Legione Calabrese (o Corpo degli Zuavi Calabri) (cfr. b. 507, ff. 20-24; si conservano tra l’altro la lettera con cui il Ministero della Guerra del Governo Dittatoriale incarica lo Sprovieri a procedere allo scioglimento in questione (MCRR, b. 507, f. 20. doc. 10, 13 dicembre 1860), sulla certificazione rilasciata dall’Intendenza Militare di Napoli in data 31 dicembre 1873 sull\'amministrazione del reparto in oggetto, una minuta dello Sprovieri sulla costituzione dello stesso, cfr. MCRR, b. 507, f. 24, doc. 9, s. d.). Per quanto riguarda, infine, la documentazione sulla Campagna del 1866, essa è relativa all’attività del VI Reggimento del Corpo dei Volontari Italiani, nel quale lo Sprovieri militò dapprima alla testa del II battaglione, poi, presumibilmente dal luglio 1866, come comandante al posto di Giovanni Nicotera, promosso generale. La documentazione (cfr. MCRR, b. 503, ff. 4-18) è meno cospicua rispetto a quella relativa alla spedizione di sei anni prima, ma rispetto a questa presenta le carte in ordine cronologico. Le tipologie documentarie, come già accennato, sono invece analoga a quelle relative alla Campagna del 1860.
Storia archivistica:
Francesco Sprovieri nacque ad Acri, il 27 maggio 1827 da Michele e Beatrice Mayerà. Negli anni giovanili la sua vivacità convinse il padre a mandarlo nel Collegio Italo-Greco di S. Antonio, ove rimase per un solo anno, essendo stato espulso per aver ordito una “congiura nella sua camerata” (cf4r. F. Sprovieri, Ricordi politici e militari, Roma 1994, p. 7). Venne quindi spedito a Napoli, per attendere agli studi giuridici. In realtà, giunto nella capitale del regno, egli si limitò all’atto di presenza all’università, entrando presto in contatto con i circoli liberali napoletani, la cui frequentazione alimentò il suo spirito rivoluzionario. Non trascurò comunque completamente gli studi, ottenendo, il 15 aprile 1847, il primo grado di approvazione nella facoltà di Belle Arti e Filosofia nella Regia Università di Napoli.All’epoca, i liberali del Regno agivano in Napoli divisi in comitati formati in base alla provincia di provenienza. Lo Sprovere frequentò quello cosentino, diretto dal barone Vincenzo Marsico, del quale guadagnò presto la fiducia, venendo incaricato di delicate missioni che lo portarono a correre da un paese all’altro per portare messaggi, istruzioni ed ordini del comitato. Luogo di ritrovo dei rivoluzionari era il Caffè Buono dei fratelli Vacca, in via Toledo, ma ben presto lo Sprovieri mise a disposizione dei cospiratori la sua casa in Figurelle Montecalvario. Prese quindi parte ad un tentativo insurrezionale, ideato da Vincenzo Mauro, che da Messina avrebbe dovuto espandersi in tutto il Regno, ma che fallì sul nascere. Nell’occasione lo Sprovieri era stato incaricato di portare in Cosenza lettere credenziali ed istruzioni. Tornato a Napoli, venne arrestato, riuscendo però presto ad ottenere la libertà in cambio di denaro. Nello stesso modo il fratello Vincenzo, anch’egli rivoluzionario, riuscì ad evitare , con la fuga, una condanna a trent’anni di reclusione. Lasciata la sua casa, che affittò ad un tale Musto, che avrebbe poi preso parte alla difesa di Venezia, lo Sprovieri continuò l’attività cospirativa, fino allo scoppiare della rivoluzione di Sicilia del 12 gennaio 1848, che generò in Napoli la dimostrazione del 27 gennaio dello stesso anno, che convinse il Borbone a concedere lo statuto. Lo Sprvieri entrò allora nella Guardia nazionale, per poi far parte, inquadrato nel 2° battaglione di volontari, della spedizione napoletana in Lombardia. Dopo il richiamo delle truppe borboniche, il patriota calabrese rimase al seguito del generale Pepe, che, posto al comando del corpo di spedizione napoletano, rifiutò di obbedire all’ordine di richiamo, dirigendosi invece a Venezia con i volontari e le poche truppe regolari rimastegli. Giunto a Venezia, il 13 giugno 1848, il Pepe venne nominato dal Manin comandante di tutte le truppe di terra. Nel frattempo lo Sprovieri, partito con il grado di 2°alfiere tra i volontari, era stato nominato dapprima caporale, poi sergente. Si distinse in particolare nella difesa del forte di Marghera, alle dipendenze di un napoletano, Girolamo Ulloa. Un altro napoletano, Carlo Mezzacapo, era a capo delle artiglierie, mentre il reparto di cui faceva parte lo Sprovieri era guidato da Enrico Cosenz. Evacuato il forte, la battaglia si spostò a Venezia, mentre il Borbone richiamò le poche truppe regolari rimaste al Pepe. Nel frattempo lo Sprovieri era stato promosso lugotenente di fanteria (28 gennaio 1849). Capitolata infine la città lagunare, si imbarcò con alcuni suoi compagni sul brik Isabella, giungendo dapprima a Missolungi, poi a Patrasso, quindi ad Atene e infine a Malta. Dall’isola si diresse poi in Sicilia, arrivando, alla fine di tante peregrinazioni, a Genova, da dove fu immediatamente costretto a partire, dirigendosi a Torino, ove ritrovò altri difensori di Venezia, facendo della propria casa un luogo di ritrovo di liberali. Nell’ottobre 1851 partì per il Parigi, dove incontrò diversi esuli, tra cui il Montanelli, il Gioberti, Daniele Manin e Guglielmo Pepe. Nel dicembre del 1851 partecipò alla lotta sulla barricate contro le truppe francesi, in occasione del colpo di stato di Napoleone III. Tornato a Torino riprese i contatti con gli esuli ivi stabilitisi, riuscendo ad evitare l’espulsione dalla città in occasione del tentativo insurrezionale del 6 febbraio 1853, dopo il quale il governo austriaco pretese l’espulsione degli emigrati politici. Negli anni tra il 1854 e il 1856, lo Sprovieri si recò in Svizzera per la stagione estiva, frequentando anche lì altri emigrati. Nella capitale sabauda lo Sprovieri continuò la sua attività cospirativa “rannodando le fila di altri movimenti che poi condussero alla guerra decisiva del 1859” (Sprovieri, Ricordi politici e militari, cit., p. 46). Nel 1857, tornato a Genova, ebbe una parte nella preparazione della tragica spedizione di Sapri, che avrebbe dovuto coincidere con un moto insurrezionale nella città ligure tale da permettere l’utilizzo delle navi del porto per correre in aiuto del Mezzogiorno. Nel 1859, in seguito all’emanazione del decreto relativo alla formazione di una brigata di volontari al comando di Giuseppe Garibaldi sotto il nome di “Cacciatori delle Alpi”, lo Sprovieri accorse immediatamente a Cuneo, dove si concentravano i combattenti, e fu inserito, in qualità di sottotenente, nel 1° reggimento guidato da Enrico Cosenz, nell’8.a compagnia comandata dal Landi. Nel combattimento di Laveno rimase ferito ad un braccio, che rimase menomato per tutto il resto della sua vita. Terminata la guerra chiese un’aspettativa, ma tornò tra i garibaldini in occasione della spedizione dei Mille. Imbarcatosi a Quarto sul “Lombardo”, nello sbarco a Talamone fu inserito, in qualità di comandante in seconda, nella 3.a compagnia, sostituendo poi alla guida del reparto Francesco Stocco. Rimasto ferito nel combattimento di Calatafimi, per il coraggio mostrato fu promosso maggiore (18 giugno 1860) ed incaricato dal generale Sirtori di formare un battaglione (2° battaglione della 3a brigata XVI Divisione Cosenz) con i resti della sua compagnia e i disertori borbonici, prendendo parte al combattimento di Milazzo. Passato sulla terraferma, e tra i primi ad entrare in Napoli, partecipò al fatto d’armi di S. Maria Capua Vetere, ormai promosso tenente colonnello e posto al comando di un reggimento. Partito per Caprera Garibaldi lo Sprovieri rimase a S. Maria con il proprio reggimento, assumendo anche il comando di una legione calabrese. Successivamente gli fu ordinato dal generale Fanti, ministro della guerra in Torino, di recarsi in Paola per prendere il comando di un reggimento di Zuavi Calabri, e fare un’inchiesta sull’amministrazione e la condotta dello stesso. In tale occasione tornò, dopo 14 anni, nella sua città natale. Tornato a Napoli, assistette allo scioglimento dei corpi dei volontari, che comportò l’invio degli ufficiali nei depositi di Cuneo ed Asti. Lo Sprovieri venne destinato ad Asti, ove ottenne un’aspettativa. Con la fusione dei volontari nell’esercito, il patriota calabrese fu richiamato ed inviato in qualità di tenente colonnello nel 6° reggimento fanteria. In occasione della spedizione garibaldina del 1862 rassegnò le dimissioni, nel timore che il suo reparto fosse inviato contro i volontari. Respinte le dimissioni chiese una nuova aspettativa, e successivamente domandò di essere collocato a riposo, venendo accontentato (R.D. del 17 dicembre 1863). Nel 1866 tornò a far parte dei volontari garibaldini, partecipando tra l’altro ai combattimenti di Cimego e Condino, al comando del 6° reggimento, nel quale aveva preso il posto del Nicotera. Il 4 settembre 1866 fu emanato il decreto di scioglimento dei corpi dei volontari, e lo Sprovieri, amareggiato per l’esito della guerra, si ritirò a vita privata, stabilendosi a Firenze.
Qui frequentò circoli politici contrari al governo in carica, e nelle elezioni del 1876, che videro la vittoria della Sinistra, venne eletto nel collegio di Corigliano Calabro, al posto di suo fratello Vincenzo, a sua volta eletto senatore. L’attività di deputato si svolse all’ombra di Giovanni Nicotera, di cui il neo-deputato seguì l’indirizzo, in opposizione al governo Depretis e al trasformismo da quello inaugurato. Egli contrastò il governo anche in relazione alle spese per le spedizioni in Africa Orientale, approvando però, dopo il rovescio di Dogali, in nome dell’onore nazionale, uno stanziamento di 20 milioni per una nuova spedizione. Nel frattempo alla presidenza del consiglio era giunto il Crispi, che lo Sprovieri, dopo 11 anni di opposizione accanto al Nicotera (1876-1887), decise di appoggiare. Nei suoi diversi mandati il deputato calabrese sostenne a più riprese gli interessi dei suoi elettori, ed in particolare denunciò le scadenti condizioni della rete stradale calabrese in occasione della discussione sul disegno di legge “Provvedimenti per la costruzione di strade nazionali e provinciali”. In un’altra occasione, nella tornata del 22 giugno 1887, perorò la causa dei facchini e operai di Genova, in merito ad una petizione da essi presentata al Parlamento, per il tramite dello Sprovieri, sulla tassa dello zucchero. La petizione fu approvata, e lo Sprovieri ricevette i ringraziamenti, tra gli altri, della “compagnia” dei “Caravana” genovesi, il cui console era un suo compagno di congiura, Giovanni Battista Casareto. Già deputato nelle legislature dalla XII alla XVI, lo Sprovieri venne infine nominato senatore con Regio Decreto del 20 novembre 1891. Per il suo contributo alla lotta per l’unità d’Italia venne più volte decorato, ottenendo in particolare la croce di cavaliere dei SS. Maurizio e Lazzaro, e quella di commendatore dello stesso ordine. Morì a Roma il 7 febbraio 1900.
Note:
A. Romeo, Antonio Cimino, Nicola Palermo, il Colonnello Sprovieri, Francesco Calfapetra, Luigi Zuppetta, Demetrio Salazaro, il due settembre 1847, Aspromonte, Reggio Calabria 1895.F. Sprovieri, Ricordi politici e militari, Roma 1894.
La documentazione è stata prodotta da:
Persone:
- Sprovieri Francesco, autore
Redazione e revisione:
- Pizzo Marco, 2005/04/16, compilazione
- Pizzo Marco, 2006/03/07, aggiornamento